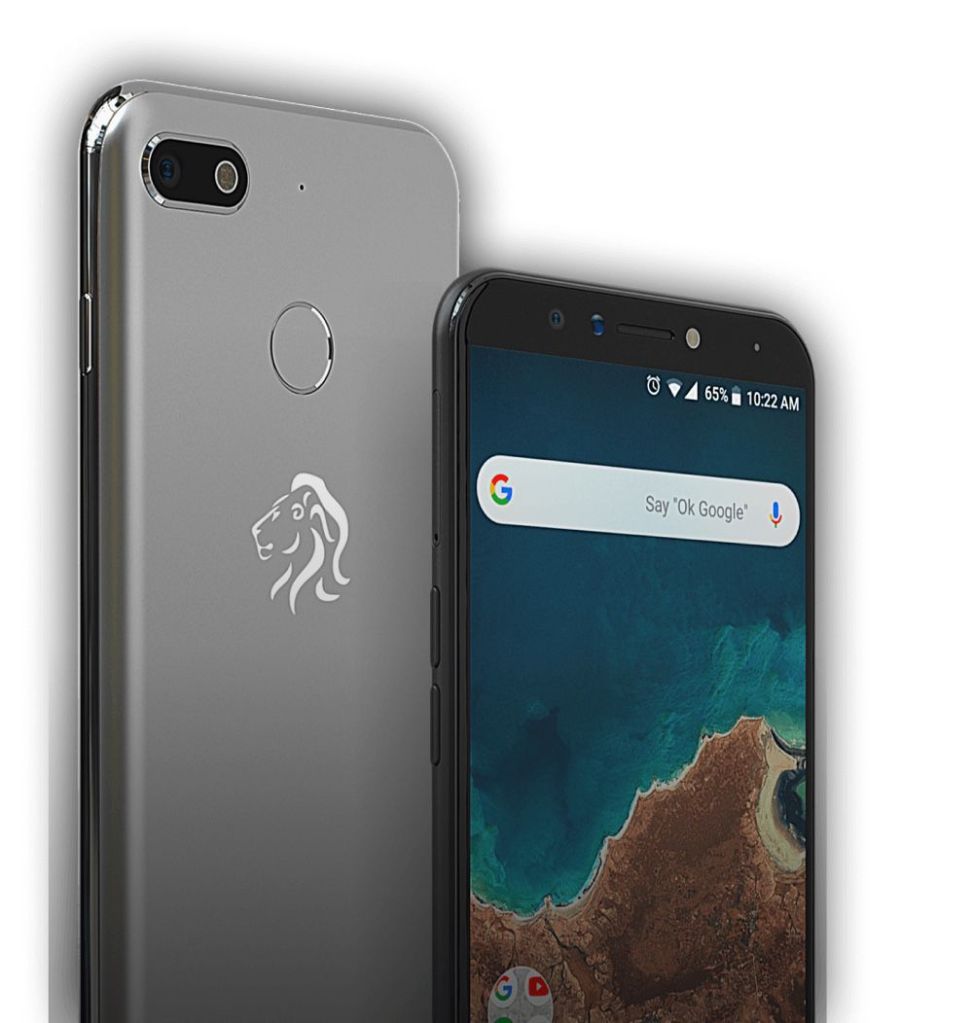Che cos’è la nevrosi? Intanto è la malattia di cui, perlomeno qui in occidente, soffre sostanzialmente chiunque respiri. Tutti, senza esclusione (ovviamente vale anche per chi scrive). La malattia è stata levata dal DSM più di quaranta anni fa, immagino per eccesso di evidenza oppure per eccesso di conflittualità inconscia (nevrotica). Ma tant’è. La nevrosi è la cosa più palese ovunque si guardi, da una strada trafficata, ai canali social, dagli studenti di un liceo divorati dall’ansia, a quelli che smangiano i tappi delle bic alla ricerca di un capezzolo ormai lontano nel tempo, da quelli che mangiano 4 volte il proprio fabbisogno alimentare, a quelli che spendono consistenti porzioni del proprio stipendio per inalare catrame e alcaloidi nei propri bronchioli, per finire con quelli approssimativi nelle consegne, per giungere ai carrieristi, che non consentono alcuna sbavatura nella conquista di un progetto. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi QUASI all’infinito (un caso da studiare a parte sarebbero secondo chi scrive le persone tormentate dal Disturbo Ossessivo Compulsivo). Ma tant’è.
Riteniamo invece più interessante segnalare, senza avere cercato neanche troppo, ciò che accomuna questa moltitudine di sintomi, ovvero un rapporto sostanzialmente insoddisfacente con la propria esistenza. Pur esaltata nei racconti con gli amici al ritorno delle vacanze, o sublimata nel conseguimento di obiettivi anche prestigiosi, guadagni esorbitanti e traguardi ambiziosi, senza che nessuna cosa riesca a suppurare la ferita che ci portiamo dentro. Solo le anime più sensibili si accorgono della vanità di tali conquiste. Polvere che si dissipa come dopo la conclusione di un Mandala, spazzata via dagli stessi Monaci che avevano costruito il mosaico. O come Cesare Pavese, che nel diario, il giorno della vittoria del premio Strega annotò: “A Roma apoteosi. E dunque?”
Di questa umanità anoressica di esistenza, ne parla con arguzia e ironia il geniale “Piccolo libro dell’Ombra”, del poeta Robert Bly, recentemente scomparso. Oppure compare come condanna sorda e feroce nelle parole di Albert Camus, Il mito di Sisifo:
“La levata, il tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno e lo svolgersi del lunedì, martedì mercoledì giovedì venerdì e sabato sullo stesso ritmo… questo cammino viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo. Soltanto, un giorno, sorge il «perché» e tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. «Comincia», questo è importante. La stanchezza sta al termine degli atti di una vita automatica, ma inaugura al tempo stesso il movimento della coscienza, lo desta e provoca il seguito, che consiste nel ritorno incosciente alla catena o nel risveglio definitivo.”
Una infinita coazione a ripetere cui la principale prerogativa è quella di non portare da nessuna parte. Uomini e donne che pattinano inconsapevoli sulla vacuità dei propri gesti, dei propri traguardi. Parole che ricordano l’ignoto autore del Qoelet “tutto è vanità”.
Ecco cos’è la nevrosi: ognuno di noi vive sul filo di un baratro, su uno strato sottilissimo di ghiaccio, al di sopra di un abisso insondabile. Vive nel presentimento che tutto possa essere vacuo e inutile.
Un abisso che percepisce, di cui intuisce flebilmente una sorta di appartenenza, ma che non riconosce, e non lo conosce perché una paura atavica lo ha allontanato quasi irrimediabilmente. Perché dentro di lui c’è ancora il puer, immerso nell’inconscio amniotico, che ritiene che nel momento in cui perderà una delle stampelle che è riuscito a procurarsi, precipiterà giù, come fanno i neonati con il “Riflesso di Moro”.
Ma tutto ha un’origine. Nella Bibbia c’è un “peccato originale”, che viene letto per lo più come l’origine di ogni peccato, mentre forse sarebbe più corretto considerarlo come l’origine della autocoscienza (“scoprirono di essere nudi”, e di ogni altra cosa (la morte, la vita, l’amore e la consapevolezza, la gioia e il dolore).
Quale sarebbe invece il “peccato originale” della nevrosi? Ce ne dà una esemplificazione geniale uno dei racconti più belli (ma anche dei più brutti) dello scrittore vicentino/milanese Dino Buzzati: Il Colombre.
Tutti abusanti, tutti abusati
Prima di entrare nel merito però devo fare una premessa, una mia convinzione personale, non so quanto condivisa dai miei amici psicanalisti (rigorosamente junghiani): ogni sofferenza è generata da un abuso, e ogni abuso genera sofferenza, sia pure in forme differenti. E abuso è, sempre secondo me, ogni scambio che avviene in una asimmetria di poteri, tra chi ne ha troppo e chi deve soggiacere senza averne alcuno. Perfino negli stereotipi la psicanalisi si occupa prevalentemente dei traumi dell’infanzia, i kindertraumen direbbe CG Jung. E se non fosse che trauma sia ogni circostanza in cui qualcuno, privato del potere di decidere debba subire la volontà di un altro? Si badi bene che, inteso in questa maniera, sarebbe traumatica e abusante anche la decisione più ragionevole presa da un genitore, come impedire l’attraversamento di una strada pericolosa, o quella di impedire allo stesso figlio esagitato di giocare a pallone vicino a un torrente in piena; il realismo (categoria un po’ troppo inflazionata) potrebbe giustificare, ma il processo psichico attivato non è detto che coincida con il pericolo evitato. Altresì sono, a mio personalissimo avviso, abusanti la maggioranza degli obblighi e prescrizioni che avvengono all’interno di una scuola. E’ logico che non si possano mandare 10 persone contemporaneamente in bagno, altresì dal punto di vista del discente dover accettare che il rapporto tra me e la mia vescica sia regolamentato da un estraneo, potrebbe essere inaccettabile. Anche se non dovesse apparire tale, buttando più facilmente il trauma – che è sempre “grande” perché riguarda la cosa più intima che ognuno di noi si porta addosso, ovvero il libero arbitrio – giù nei recessi dell’inconscio. Laddove, non più veduto, potrebbe caricarsi di ombre e diventare più potente di quanto si immagini.
L’orologio di Buzzati
Infine, prima di entrare nel racconto di Buzzati, mi tocca fare un’ulteriore premessa – l’ultima. E riguarda il tempo. Il tempo della nevrosi (e dei nevrotici) è apparentemente lineare, piatto, sostanzialmente ripetitivo. Il suo immaginario si è radicato nella rappresentazione di Isaac Newton, del cosiddetto “tempo lineare”. E la linearità risulta da un certo punto di vista confortante, perché prevedibile, ancorché ineluttabile e irreversibile. Chi vive nella linearità costruisce per sé una esistenza protetta. I giorni scorrono uguali. Perché ciò che è diverso fa paura.
E’ la paura, il vero collante della nostra società, diventa il tutto per ogni rappresentazione del vivere. Dalla pubblicità: “…e passa la paura!”, ho ascoltato recentemente la conclusione di uno spot radiofonico. L’oggetto era un software gestionale per le buste paga; “Così sai cosa aspettarti.”, gli fa eco un altro. Quando qualcuno entra in ospedale, magari per una operazione, noi gli auspichiamo “Andrà tutto liscio!” che a mio modo di vedere aggiunge anche l’assenza di attriti. E’ così che noi disegniamo il tempo, come un tubo lubrificato entro cui trascorrere l’esistenza, toccando/lasciandosi toccare da meno cose possibili. Abbiamo creato un sistema complesso, ed estremamente variegato di entertainement il cui principio è “passare il tempo” senza attraversarlo e senza esserne attraversati, senza viverlo, senza assegnargli un valore. Riducendolo semmai a un disvalore, perché il tempo è un problema, è noioso – una conseguenza inevitabile. Ai miei studenti dico che è statisticamente probabile “sbagliare” molte scelte nella vita, a partire dalla scuola (sulla quale grava il forcipe della obbligatorietà), università, relazioni, e lavoro. Talmente frequente, d’avere creato stereotipi, luoghi comuni e persino barzellette. Si vive la settimana per il venerdì, si odia il lunedì. Si agognano le vacanze. Si vorrebbe divorziare, ma non si trova la forza per farlo. Si trova un lavoro diverso da quello desiderato. Insomma, si finisce per detestare ciò che, in qualche misura almeno, ci compete fare. Si finisce per vivere dove non si vorrebbe. Per tenere i piedi su una terra che non è mai stata la propria. Principalmente questo diventa causa di depressioni – persone che perdono l’oriente, e declinano verso l’occaso, dove il sole muore. E muoiono, persino quando sono in vita. E se diventano anziani, affogano nella depressione – la medicina da alcuni decenni si è specializzata enormemente, raggiungendo standard di cura inimmaginabili solo poco tempo fa, aggiungendo anni e anni di aspettativa di vita, puntando inconsciamente all’immortalità – rendendo i medici i sacerdoti di un nuovo culto, signori della vita e della morte, con tanto di cattedrali, paramenti e liturgie, una fede che si fonda (un po’ come tutti) sulla paura della morte.
Certo non è infinita, sicuramente non per chi respira, e questo noi nevrotici lo temiamo come la morte, perché sarà proprio la morte, il da-sein Heideggeriano a infrangere tutte le difese fino a quel momento adottate. Che Newton avesse torto è stato largamente documentato dalle acquisizioni della relatività, e ancor più dalla quantistica. Tuttavia l’immaginario per noi continua a essere quello scientificamente superato, perché ciò che è lineare sembra più facile da gestire. Ma già i Greci celebravano almeno un’altra forma di temporalità, Kairos, accanto a Kronos (un padre abusante che divora i figli). L’occasione improvvisa, l’insight, il balzo in avanti – ma anche in alto e forse persino verso il fondo – a fianco dello scorrere lento e ineluttabile del gregge di nuvole sul tappeto azzurro del cielo, o sui fondali dove si nascondono i relitti e le cose. Dove sono dimenticate. Dove ci sono i tesori dimenticati. Anche se questo non traduce esattamente ciò che intendo, è già qualcosa. Ciò che io penso è che occorra, accanto alla dimensione orizzontale del tempo, un’altra verticale, quella dove magari il ghiaccio si spacca e ci si immerge, o ci si eleva. Ed è la dimensione del significato, del perché, del valore reale che si attribuisce alla realtà intera, alla propria vita. Il tempo verticale è quello dove si ama, ama davvero, profondamente senza calcolo, perché questo è l’unico accesso al significato, al valore – reale o attribuito, non importa – di tutte le cose, il punto dove ci si immerge nell’Abisso della propria esistenza. Un momento estremamente doloroso, come la nascita, o come la morte. Il momento in cui si scende a considerare l’inconscio, che ci permea, ci fa gioire, soffrire, desiderare, amare e odiare. Vivere, diversamente dalla farsa imbastita della nevrosi.
Sinossi
Tracciamo intanto una breve sinossi del racconto, pubblicato da Buzzati il 22 agosto 1961, venendo inserito successivamente nella raccolta Il Colombre e altri cinquanta racconti.
Curiosamente nella successiva raccolta, più nota, “La boutique del Mistero”, la centralità del Colombre non verrà ribadita quantomeno nel titolo. Del protagonista, Stefano Roi, qualcosa s’è detto. E’ un dodicenne dapprima allegro e solare, che accompagna il padre, capitano e proprietario di una bella nave da diporto, a fare una traversata. Ma quasi subito si accorge che a prua uno strano oggetto lo sta seguendo. Quando il padre lo raggiunge, imbraccia un cannocchiale e cambia espressione, dalla gioia al terrore. Quel “puntino” che segue la nave
“è un Colombre, È il pesce che i marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell’uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima, e quando l’ha scelta la insegue per anni e anni, per una intera vita, finché è riuscito a divorarla.”
E il Colombre cerca proprio Stefano. Così il piano del viaggio viene immediatamente stravolto, Stefano riportato frettolosamente al porto da cui era salpato. Da quel momento il ragazzo viene allontanato dal mare (ndr: Buzzati usa un’altra espressione, “distolto dal desiderio”), e mandato a studiare – e vivere – in una città dell’interno. Ma pure lì, al sicuro, quello squalo diventa una “segreta ossessione” per cui, quando il padre muore, torna alla città in cui era nato e comincia a navigare. Dapprima come marinaio semplice, poi con l’eredità paterna si prende un piccolo piroscafo e infine un mercantile. Naviga sempre, e sempre dietro alla sua prua c’è il Colombre. Ma Stefano è paralizzato tra l’attrazione e la paura (su questa ambivalenza Buzzati gioca di continuo), fino a quando invecchia e decide, in punto di morte, di andare finalmente a sfidare la bestia. Ma quando questa emerge a fianco del barchino, scopre che intanto il Colombre parla, e non ha mai avuto intenzione di divorarlo, ma soltanto di elargirgli un dono del re degli oceani, la “famosa” Perla del Mare,
“che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell’animo.”
Ormai però è troppo tardi. Così i due si congedano, e pochi giorni dopo alcuni pescatori avvistano un barchino sul quale, ancora ritto, c’è uno scheletro bianchissimo, tra le cui falangi stringe ancora
“un piccolo sasso rotondo”.
Il padre abusante e la trasformazione abortita
Ma la nevrosi ha ancora un punto, una scaturigine, una ferita antica che in pochi percepiscono di dover curare. Ogni atto subito da chi non ha potere è abuso, ma ve ne ne deve essere uno che abbia avuto il potere di perforare il carapace della normalità.
Tutto questo lo si ritrova ne Il Colombre. Ed è curioso che proprio questo racconto sia, forse, quello con il linguaggio più scarno, quasi cacofonico. L’unico nome che viene fatto in tutto il racconto è quello del protagonista Stefano Roi. Per il resto viene conferita una (breve) fisionomia al padre – abusante, ma tutti gli altri, pochissimi, personaggi, non sono che sfumature che immediatamente si perdono. Persino la madre è un carattere del tutto evanescente, completamente avulsa dalle scelte del marito prima e dalle angosce del figlio dopo. Per non parlare dei compagni di navigazione di Stefano, cui al massimo si può conferire il rango di ombre. C’è un altro personaggio pervasivo, insistente, inesorabile, insistente, irreversibile proprio
“come gli strumenti del fato”
Ed è proprio il Colombre, il convitato abissale.
Una curiosità: le esistenze dei protagonisti si consumano in un tempo accelerato – scivolano come sul ghiaccio. Il padre nel momento antecedente all’avvistamento del Colombre, dapprima afferma
“Nonostante i miei quarant’anni credo di avere ancora una vista buona. Ma non vedo assolutamente niente.”
Vive in un mondo dove un quarantenne normovedente deve usare un “nonostante” per giustificare una piccola defiance. Ma forse non ha tutti i torti se soltanto una decina di anni dopo muore “per (una) malattia” sulla cui natura non si sofferma. Invece Stefano morirà “vecchio, vecchissimo…” sebbene abbia – Buzzati ci fornisce i numeri da calcolare – tra i sessanta e i settanta anni.
Stefano Roi è un personaggio di una solitudine senza paragoni. Eppure la sua vita, all’inizio del racconto, viene mostrata nel modo più solare possibile. Tutto comincia con una promessa di gioia incontenibile, quale l’infanzia (o la preadolescenza) dovrebbe essere:
“Quando Stefano Roi compì dodici anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo: «Quando sarò grande» disse «voglio andar per mare come te. E comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua.» «Che Dio ti benedica, figliolo» rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole; e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di quello ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni.”
Tutto è solare, come solare dovrebbe essere l’infanzia, sino al suo stereotipo. La giornata è appunto splendida, i marinai sono pazienti e sorridenti, aperti al dialogo, c’è un magnifico vento al giardinetto. Meglio di così, si direbbe, non potrebbe andare.
Essendo tuttavia un momento di passaggio deve accadere un contatto con l’ombra. Ma ecco che spunta il latore dell’Ombra, il messaggero dell’Abisso, l’agente delle profondità dell’universo, il Colombre appunto. Non ancora il nemico (non ci sono gli elementi per classificarlo tale, non ci saranno anzi mai, al di là di leggende e superstizioni). Già alla sua comparsa il mostro rivela immediatamente la propria natura ambivalente, la benedetta ambivalenza junghiana, che verrà ribadita ovunque lungo le pagine del racconto:
“E, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, che lo attraeva intensamente.”
Questa attrazione, è un presentimento, che dovrebbe fare del pescecane un attore necessario della scena, il portatore – della perla non possiamo ancora sapere – del cambiamento necessario. Si sta recando, con la sua offerta, sotto l’altare affinché il rito possa essere celebrato. Sicuramente il pescecane è il latore dell’ombra, senza il cui contatto ogni trasformazione è sempre formale e incompleta. Gravemente incompleta.
A questo punto giunge il capitano – in questo passaggio la veste di ufficiale si confà più di quella di genitore. Individua quel puntino, che è appunto uno “squalo misterioso”, e cioè pericolosissimo, perché non vi può essere che qualcosa di malvagio e minaccioso nel mistero. Si celebra in questa idiosincrasia la paura del non manifesto, dello sconosciuto. Incomprensibile diventa sempre sbagliato.
L’ufficiale non ha informazioni di prima mano, confessa di non averne mai visto uno, ma si basa su una fittissima ed autoalimentata rete di “si dice” che non lascia scampo alla celebrazione. A questo punto prende una decisione, che cambierà per sempre la vita di Stefano (molto meno la propria). Non appena individuato l’animale, dimostra la meschinità – anzi, la raddoppia – di tanti adulti, che preferiscono accusare i figli piuttosto che assumersi le proprie responsabilità:
“Oh, non ti avessi ascoltato» esclamò il capitano. «Io adesso temo per te.”
Il verdetto di colpevolezza è stato emanato in rito abbreviato. La primissima responsabilità non può essere ovviamente caricata sulle spalle del padre, e neanche del numinoso pesce (che in fondo fa – dovrebbe fare – ciò che ci si aspetta da lui). Il primo ad avere sbagliato è proprio il piccolo Stefano. Come si è permesso di manifestare il proprio desiderio? Di avere desiderato un Destino? Peggio: come si è permesso di coltivare un desiderio? Ha rovinato tutto, e il peso di questo disastro lo deve portare come un Atlante solitario quel sant’uomo del padre. Da questo momento – io adesso temo per te – infatti il problema non sarà che il figlio venga inseguito da un mostro per il resto dei suoi anni, ma i timori che questa condizione potrà generare nel genitore (meno di quanto si possa pensare tuttavia).
Ma non si vergogna quel dodicenne brufoloso di causare tante angosce in chi ha fatto così tanto per lui?
Ma la meschinità più profonda deve ancora arrivare:
“Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo. Devi rassegnarti.”
Persino il capitano ne è consapevole. Con questa mossa a Stefano non viene sottratto un hobby, ma il Destino medesimo. E per essere sicuro che il sopruso venga portato a temine, esige un patto, quell’odioso “me lo devi promettere.” Ma in base a che, qual è il principio da invocare perché quello sia un “debito”, un “dovere” se non l’estorsione al figlio indifeso, che non in grado di opporre alcun tipo di resistenza, Il “patto” – ma è un atto criminoso – viene richiesto e ottenuto in base alla inermità dell’interlocutore. Qual è la controparte del patto? Dov’è il “do ut des”, la controparte, il vantaggio conseguito dalla parte più debole? Non c’è, semplicemente. E Buzzati dice molto chiaramente, quale sia invece l’unico a guadagnarci dall’invenzione di quel debito, dalla prevaricazione, ovvero il Padre – il cui obiettivo NON E’ al di là dei proclami – la salvaguardia del figlio, ma il non doversene più preoccupare: insomma… preservarsi dall’ansia.
Lo testimoniano i passi successivi. Infatti
“Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e, col pretesto di un improvviso malessere, sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. ”
(Il tema del Colombre, viene trattato con i crismi della vergogna, dell’onta e infine dell’ombra, per cui chi ne viene “infettato” è solo; non tanto per l’ostinazione del pescecane, ma soprattutto per l’esclusione della comunità umana. E’ una macchia dalla quale è impossibile decontaminarsi perciò tanto vale tenerla occultata. Anche Stefano si comporterà così fino agli ultimi istanti della sua vita), il ragazzo viene sbarcato e la nave – e il suo capitano – si allontana dall’appestato senza troppi fronzoli o ripensamenti.
“Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l’ultimo picco dell’alberatura sprofondò dietro l’orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque: il ‘suo’ colombre, che incrociava lentamente su e giù ostinato ad aspettarlo.”
Non c’è possibilità di elaborazione, oltretutto il ragazzo viene ulteriormente messo in pericolo. E’ sufficiente pensare a questo: un ragazzo inseguito da un pericoloso squalo, si trova in una condizione più pericolosa a bordo di una solida nave, confortato dalle attenzioni del padre – un padre diverso, a questo punto – e di chissà quanti altri marinai, avvertiti (forse) del pericolo e allertati a intervenire qualora il ragazzo si sporgesse da una balaustra, oppure lì, scaricato dalla nave e dal suo sogno, dal padre e dal destino, definitivamente solo, abbandonato, frastornato sulla riva di un mare “completamente deserto”? E’ talmente confuso che, chissà, potrebbe anche tentare un gesto disperato, lanciarsi a nuoto verso quella nave da cui è stato sbalzato, come un accessorio inutile,
Superfluo dire che il padre di Stefano – e chissà quanti altri – inverano la profezia di Betsy Karasik che qualche anno fa sul Washington Post. seguendo una polemica nazionale, scrisse di avere l’impressione che i genitori cercassero di tutelare se stessi dalla (possibile) accusa di non tutelare i figli, che tutelare effettivamente questi.
Il padre di Stefano si comporta esattamente così. Impone – non propone – un patto, le cui parti sono separate da una asimmetria insanabile. Come il Dio degli Israeliti sottopone al suo popolo un contratto, dove però le condizioni sono gravemente impari.
E quale sia il vero interesse del capitano lo documenta non solo con le parole, ma anche coi fatti. Abbandona immediatamente e letteralmente il figlio al suo destino (quale che sia). Il racconto di Buzzati non li mette più l’uno di fronte all’altro. L’uomo adulto avrebbe potuto fare mille cose diverse, dimostrare una intelligenza educativa che, evidentemente, non ha mai avuto interesse a coltivare: suo figlio ha appena perso quello che ha sempre considerato il suo destino, e lui non muove nulla. Potrebbe, per fare un esempio, rinunciare a quello specifico viaggio, lasciarlo condurre al comandante in seconda, e fermarsi a casa a parlare con quel bambino traumatizzato. Fare lunghe passeggiate lungo il mare – il colombre non ha le ali – fargli comprendere che il legame con l’Oceano non lo perderà mai, anche se dovesse rinunciare a navigare. Infine, cosa non da poco, potrebbe accettare di farsi carico di qualche preoccupazione in più, e lasciare Stefano decidere per se stesso.
Ma questo è un livello di consapevolezza cui pochi genitori riescono a raggiungere. Non lui.
Nel “Piccolo libro dell’Ombra” Robert Bly racconta un episodio, accaduto a un conoscente, che documenta quanto si possa agire diversamente. Europa, seconda guerra mondiale, i nazisti stanno cominciando a cercare ovunque gli ebrei per la deportazione. In un certo villaggio, con una forte componente ebraica, tutti sono ovviamente preoccupati per quello che sta per succedere. Al centro della comunità israelita c’è proprio la famiglia di quello che diventerà l’amico di Bly, ancora bambino. Poiché la sua abitazione era “invasa” di persone che chiedevano un consiglio, o un aiuto anche in momenti di pace, tanto più adesso, quando le SS e le loro camionette si facevano sempre più vicine. Molte persone si aggiravano nella sua casa, nel suo habitat senza nascondere l’angoscia di quel momento. Ma il bambino non poteva capirne le ragioni e, siccome quella mattina nessuno aveva provveduto alla sua colazione, l’ansia si era trasformata nella protesta per non aver ancora ricevuto nulla da mangiare. Così una cameriera, anche lei indaffarata nei preparativi di fuga, non riuscì a fare di meglio che dargli un pezzo di pane. Ma la fame non era il vero motivo di quella rabbia così il bambino lo prese e lo scaraventò in terra, per protesta. Conosco molti genitori, sedicenti educatori, che davanti a un capriccio del genere – perché poteva sembrare un capriccio – si sarebbero sentiti autorizzati ad impartire una lezione di realismo, magari con uno sganascione. Per fortuna capitò proprio in quel momento il nonno, la figura più carismatica della famiglia quando vide il gesto, raccolse il pane, lo baciò e lo restituì al più piccolo. Non reagì come avrebbero fatto la maggior parte degli adulti, non utilizzò le “la straordinarietà delle circostanze”, per mortificare chi aveva fatto – o sembrava – un capriccio in un momento simile. Con un gesto elementare non eliminò la sensazione di pericolo, ma gli comunico che quel pericolo poteva essere affrontato, insieme. Baciato, appunto.
Quello dell’esempio si pone all’esatto opposto del comportamento del Padre di Stefano: la sua è una imposizione, che si regge su un ricatto, un patteggiamento senza controparte, volto esclusivamente a uno scarico di responsabilità.
Che la sua priorità sia se stesso e non il figlio, Buzzati lo sottolinea poco dopo. Perché dopo che Stefano viene brutalmente allontanato dal paese natio, e mandato a studiare in una città dell’interno, una verifica l’abbiamo quando, per le vacanze estive, a un certo punto il ragazzo torna a casa. Immaginiamo che torni in treno, ma alla stazione non lo va a prendere nessuno. Gli adulti sono affaccendati in cose da adulti, a gestire egocentricamente la porzione della relazione che li riguarda – questo come detto non vale per la madre, che del Colombre non sa nulla. Il padre letteralmente non se ne occupa. Così Buzzati descrive, nel suo modo sotto testuale, una sequenza davvero impressionante:
“Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l’estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo.”
Qual è la ragione per cui si manda un figlio a studiare “al sicuro” da un pescecane ostinato, se poi, quando questo fa capolino in città lo si lascia solo con risultato: “prima cosa”, “minuto libero”, “si affrettò”, “estremità del molo”, sono tutte espressioni che descrivono la premura, il correre, ovvero esporsi al pericolo più grande che si possa immaginare? Se stefano fosse inciampato e caduto in acqua e fosse stato divorato dal Colombre? Il padre probabilmente avrebbe al funerale rivelato – a quel punto cosa sarebbe servito mentire – del pescecane, avrebbe altresì detto di avere fatto di tutto perché lui potesse stare al sicuro, lontano dalla bestia immonda. L’allontanamento in città, la promessa stessa carpita, il silenzio con la moglie, affinché non si angosciasse, non erano la miglior prova di quanto fosse stato integerrimo e responsabile il suo comportamento?
Ma non è vero.
Tuttavia il diktat paterno non viene mai smesso in discussione. Nemmeno dopo la morte del beneficiario del patto surrettiziamente imposto. Questa è la debolezza psichica che comporta la nevrosi, una grave nevrosi. Stefano rimane prigioniero dell’anatema paterno, non riesce a prenderne le distanze. Tuttavia non riesce mai a distaccarsi neanche dal Colombre. Una oscillazione piena di inquietudine, alla quale manca l’elemento risolutore – in un modo o nell’altro -, ovvero il conflitto. Ondeggia tra il ponte della nave e il mare aperto – anzi, il ponte diventa proprio il luogo dove riesce a mantenere il precario rapporto “non conflittuale” tra gli estremi:
“Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra in qualche porto, subito lo pungeva l’impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c’era il colombre ad aspettarlo, e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie, da un oceano all’altro.”
Finché vive in città diventa per lui “una segreta ossessione”. E’ chiaro che centinaia di chilometri lo separano dal pericolo, ma lo ha interiorizzato, collocato in una dimensione intrapsichica tale per cui la distanza non sarà mai abbastanza. Il “mostro” è penetrato, fa parte della sua persona, diventa la sua Ombra, ma Stefano come tanti non è in grado di valorizzare l’ambivalenza, di dare un valore positivo all’attrazione, e quindi sfugge il contatto, tenendo l’origine delle sue paure rigorosamente alle spalle.
“Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatta la sua vita, ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio; e, passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora più grande è l’attrazione dell’abisso.”
Ma cos’è questo “Abisso”. In parte abbiamo provato ad accennarvi come al nostro inconscio. Proveremo ora ad essere più specifici. L’Abisso è il luogo della generazione dei contenuti – qualsiasi contenuto – di significato. Molti miti/religioni evocano le figure di un Dio che scende negli abissi per completare la propria “missione”. Lo stesso Messia cristiano, ma prima di lui Inanna, Eracle, il Ciclo di Baal, Jona nella Balena, Maometto condotto dall’Arcangelo Gabriele sul dorso del cavallo Buraq, il viaggio di Orfeo alla ricerca (infruttuosa) di Euridice, Gilgamesh che si immerge sul fondo dell’Oceano dietro indicazione del vecchio Utnapishtim, il quale gli indica dove è ubicata l’erba della vita eterna (che tuttavia gli viene sottratta da un serpente). Amore, morte, immortalità… l’Abisso è il luogo delle cose vere, perché è il luogo delle cose ultime, definitive. Nella vita di un uomo poche cose sono “abissali” (sebbene più di quanto ce ne si accorga. Abissale è la vita medesima, quantomeno la sua origine, la sua conclusione, il dolore, e se anche meno di moda, anche la gioia). Tutto è lì sotto, bloccato, imprigionato dietro mura tetre, coperto da veli deformanti e spaventose. Ma occorre “toccare l’ombra”, accettare il conflitto – nel caso di Stefano con il padre, o con la sua memoria. Altrimenti si vive, si sopravvive per un lasso di tempo, per poi scoprire di non avere vissuto.
“«Ahimè!» disse scuotendo tristemente il capo. «Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza: e ho rovinato la tua.”
L’uomo contemporaneo è dissolto nel suo primo pavor nocturnus, nevroticamente incapace di spegnere, o superare quel terrore divorante, della notte, del buio e delle sue creature. Ovviamente non ne è cosciente – sarebbe un grande vantaggio poterlo capire. Rimane imprigionato nelle proprie piccinerie, nei gesti ripetuti senza motivo, nell’andare senza domandarsi dove. E così la maggior parte delle persone vivranno senza conoscere l’amore, senza l’autentica coscienza della propria mortalità, non avrà guardato l’origine delle origine, e la finalità di tutti i fini, spegnendosi alla fine come il mozzicone dell’ultima sigaretta di una caldissima estate.
Ed ecco perché il protagonista del mio prossimo romanzo semiautobiografico si chiamerà Stefano Roi.