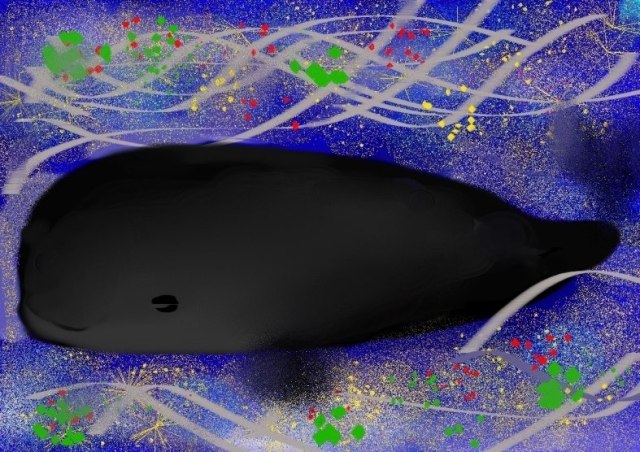“Se l’Amore è Dio, forse è anche eterno, e l’indissolubilità coniugale potrebbe essere una conseguenza di questa verità…”, don Patrizio dopo il lungo silenzio aveva scelto una tempistica perfetta per tentare di sigillare la discussione in un modo congeniale al ruolo che pur sempre rivestiva, “Non credi Piero?”
L’amico lo guardò con una irruenza tale da metterlo in imbarazzo:
“Certo che in ogni amore, se autentico, c’è qualcosa che resiste al tempo. Ma non nel modo vagamente ricattatorio come intendono i tuoi superiori. È una eternità mai esigibile, la cui principale caratteristica è che lascia le persone libere di fare ciò che vogliono: per quanto questo possa essere doloroso, o per quante convinzioni possa infrangere. Una pianta perenne verde che avvizzisce nell’istante stesso in cui qualcuno pensa di avere diritto alla sua ombra. Una eternità gracile come la brina, pronta a dissolversi al primo raggio del possesso. Un infinito che finisce non perché uno dei contraenti rompe il patto, ma perché l’altro esige che venga rispettato.”
“Don, ecco le chiavi.”
Don Patrizio guardava l’uomo trafelato che gli porgeva un enorme mazzo, precario su un vassoio di sedie di plastica impilate, mescolando tenerezza e orrore. Ma Alberto, buono come il pane, non se n’era avveduto. L’unico timore che poteva divorarlo era d’essere utile, e utile lo era. Eccetto che per un leggero strabismo, il suo aspetto non denunciava il deficit che gravava sulla sua anima semplice, e che sin da bambino gli aveva procurato affetto e derisioni in egual misura. Ora, a quarant’anni suonati o giù di lì, era un uomo fatto e finito, aveva un fisico che in molti gli avrebbero invidiato se sulla sommità non ci fosse stata la testa di un fanciullo. Troppo spesso, poi, il sollievo di non doverlo invidiare si trasformava in cattiveria. La mente di Alberto era un cristallo limpido, che il sacerdote doveva sforzarsi per non uscire dal confessionale, abbracciarlo e cercare di sollevarlo un po’ dal tetro senso di colpa quando veniva a cercare redenzione per non essere riuscito a non desiderare ciò che la sua natura reclamava, e che egli poteva compiacere nell’unico modo accessibile agli uomini meno ambiti dalle donne. Nell’unico che conosceva. Il suo voto di castità non era mai stato pronunciato, eppure Alberto si rifugiava in un surrogato laicale per tenersi lontano da qualcosa che finiva per ritenere più spaventoso che sbagliato. O sbagliato in quanto spaventoso. Don Patrizio avrebbe voluto prendere in disparte uno dei tanti mariti che tengono un piede – quello più confortevole – nella pantofola della famiglia e di un ammuffito timor di Dio, e l’altro abbondantemente fuori, e assegnargli come penitenza di portarsi Alberto appresso in uno dei propri pellegrinaggi sessuali, e consentirgli di trarre giovamento dall’incontro con una femmina in carne ed ossa, piuttosto che le proprie fantasticherie irrequiete. Vi sarebbe, pensava, riscatto e almeno un po’ di gloria per tutti, se era vero che le prostitute avrebbero nel giorno del Giudizio sopravanzato tanti pubblicani – e altrettanti preti – davanti alle porte del Paradiso. Ma certo non poteva essere lui, un presbitero della chiesa di Cristo, a dare un simile suggerimento, e si limitava ad affidarlo a piani più imperscrutabili dei suoi. Sebbene i tormenti di Alberto lo mettevano a disagio, la genuinità con la quale questi era uso ad accogliere gioiosamente l’assoluzione lo facevano poi stare bene. Quantomeno meglio. Chi era lui per giudicare? Almeno questo, dal Vangelo, l’aveva imparato.
Non l’avrebbe mai ammesso neppure con se stesso, ma don Patrizio aveva trovato la quadra raccontandosi che se la chiesa da una parte chiedeva troppo, dall’altro era straordinariamente generosa, perché non ci fosse stata la parrocchia di San Giovanni Crisostomo, dove sarebbe potuto stare uno come Alberto? In quale altrove egli si sarebbe potuto sentire altrettanto a casa propria? Chi gli avrebbe consentito di sentirsi importante?
“Grazie Abe, sono tutte fuori le sedie?”, gli domandò per dargli la considerazione per lui talmente importante.
“Certo, don!”
“Hai messo le bibite nel frigorifero oggi pomeriggio?”
“Sissignore!”, rispose Alberto sorridendo e sollevando, sempre con le sedie in mano, le spalle per somigliare ad un militare.
“Va là, che senza di te qui crollerebbe tutto. Dai, molla le sedie accanto al calcio balilla e poi vai a casa, che se no la mamma mi chiama per sapere dove sei.”
“Va bene.”, fece Alberto, cui la prospettiva di rincasare però non piaceva mai troppo. Fosse stato per lui, si sarebbe piantato stabilmente all’oratorio. E, considerando che la madre oramai contava più di ottanta primavere, non era detto che un giorno non ci avrebbero dovuto pensare.
“Ah, fammi un ultimo favore, Abe.”, fece il presbitero che intanto si stava allontanando con il mazzo di chiavi in mano, “Abbassa la catena del cortile, che deve arrivare il mio amico. Gli ho detto di parcheggiare lì.”
“Che macchina ha il tuo amico, don?”, fece Alberto mostrandosi poco interessato al resto.
“Ah guarda…, non saprei.”, disse don Patrizio passandosi la mano tra i capelli, “Forse una di quelle che vanno adesso, un macchinone grande e grosso, verde scuro se ancora ricordo.”
“Ma don, per te qualsiasi cosa che non sia una Punto è un macchinone grande e grosso.”, disse Abe con un sorriso canzonatorio, “Comunque la catena l’avevo già abbassata, e mezz’ora fa è arrivata una Toyota RAV 4, del 2008.”
Don Patrizio emise una sorta di grugnito, senza ringraziare; che Alberto avesse dei punti di lucidità assoluta, nei quali dimostrava addirittura una mente brillante lo sapeva. Che la sua passione fossero le automobili, altrettanto. Non gli garbava invece che quegli sprazzi fossero usati per cercare di far passare qualcun altro – quasi sempre lui – per deficiente.
Si avvicinò al vetro della porta che introduceva al cortile, e il macchinone parcheggiato era lì. Ma nessuna traccia di Piero. Arrivare in anticipo era proprio da lui, ma come mai non l’aveva visto? Aprì la mano destra sulla fronte a sfidare il raggio di sole che trafiggeva il vetro. Niente. Allora spinse con forza il maniglione antipanico e uscì. La serratura gli obbedì docilmente. Ci mise alcuni secondi per abituare la vista, oramai il mese di ottobre avrebbe dovuto digradare verso la parte più fredda dell’autunno, ma da quasi dieci giorni un sole stranamente euforico aveva preso a contraddire i meteorologi e il buon senso. Un anticiclone, con il nome di non ricordava quale imperatore romano, aveva spinto una impertinente propaggine d’estate dentro il ventre flaccido dell’inverno. Di Piero neanche l’ombra. Non aveva voglia di gridare, perciò decise di continuare a camminare. In che direzione però non sapeva. Si lasciò guidare dall’istinto. Oltrepassò il cortile, entrando nel passaggio che conduceva alla canonica, e di lì proseguì fino all’oratorio. Giunto in prossimità dei giochi, vide una sagoma scura, in controluce, di spalle, che fumava seduta dondolandosi lentamente su un’altalena.
“Guarda che la rompi, e poi ti tocca pagarla.”, gridò alla sagoma fingendosi arrabbiato. L’uomo, senza scomporsi, si voltò lentamente e, aspirando una boccata particolarmente lunga, rispose flemmatico:
“Peso almeno venti chili meno di te. Non sono io quello che ricorda i peccati di gola sono quando conviene.”
L’uomo dietro la nuvola di fumo lo fissava con una finta indolenza. Gli occhi castano chiari, con una sfumatura verde, erano saldi e sinceri. Aveva una corporatura proporzionata, sebbene non fosse particolarmente alto. Il volto, solcato dal passaggio alla mezza età, era una corteccia che ci si aspetta di trovare nelle persone particolarmente riflessive. I capelli lunghi e brizzolati, dovevano essere stati pettinati con cura qualche ora prima, avevano ceduto all’entropia del vento, anche se ogni tanto la mano sinistra tentava di porre un argine. Nell’abbigliamento strideva il contrasto tra un vestito grigio scuro, certamente di pregio, con l’assenza di una cravatta e il giubbotto trapuntato di materiale sintetico blu, che elegante non era.
“… che poi, chi sono io per venire a giudicare il modo con cui il mio migliore amico cerca di compensare col frigorifero ben altre e più innaturali privazioni?, disse l’uomo dietro ad una nuova gettata di fumo alabastro.
“Davvero non riesci ad accettare che qualcuno possa scegliere la castità? Non si tratta di un rerum contra naturae, ma di un ordo soprannaturalis.”, rispose don Patrizio fingendo di prepararsi per una rissa teologica, “Vecchia canaglia d’un cinico che non sei altro. Dai vieni qui e fatti abbracciare…”
L’uomo si alzò dall’altalena, gettò la cicca a terra e la schiacciò con la punta del mocassino, certamente comprato in un negozio del centro, poi si avvicinò a don Patrizio aprendo un sorriso sul quale si dipinsero le fossette con le quali aveva ammaliato molte giovani donne. Era certamente un uomo affascinante.
Si abbracciarono con trasporto, come del resto facevano ogni volta che le circostanze della vita non glielo impedivano. Si conoscevano da tempi remoti, da quando erano adolescenti, impiegata spendendo il proprio entusiasmo dentro ai movimenti cattolici, finché Piero non se n’era allontanato. Ma aveva mantenuto – questo era almeno un convincimento radicale in don Patrizio – una spiritualità strutturata, sebbene distante dalle forme tradizionali in cui il popolo cattolico s’era incaponito. Molto distante.
“Era da un po’ che non mi invitavi a parlare ai tuoi fidanzati. Per caso hai cominciato a ravvederti? Forse hai cominciato l’apostasia con cui tornare sulla retta via? Ti sei infine deciso a schiodarti dalle soffocanti tutele del tuo vescovo?”
Don Patrizio non raccolse la provocazione, ma in effetti il modo “non proprio opportuno di condurre un corso per fidanzati di preparazione al Sacramento del matrimonio”, così aveva formalizzato la propria contrarietà il vicario quattro anni prima, in un modo talmente indiretto che dubitò a lungo che stesse parlando proprio di lui. O con lui. Problemi. In quella comunicazione, apparentemente colloquiale, vi era un richiamo gelido a non discostarsi troppo dai sentieri più conosciuti, nella scelta di letture e testimonianze da lì in poi. Lo tenevano d’occhio e ora glielo avevano pure fatto sapere. Don Patrizio aveva colto il messaggio e a malincuore obbedito. Ovviamente della cosa non aveva reso partecipe Piero, ché non avrebbe chiesto di meglio per buttare benzina sulle vampe che lo avevano portato lontano dalla madre Chiesa. Non voleva essere lui a dilatare ulteriormente la misura di quella separazione. Però in cuor suo non riusciva a non pensare che qualche ragione Piero potesse pure avercela. Che la chiesa fosse reticente davanti alle novità, che dal grembo di quella madre difficilmente venissero partorite esperienze e linguaggi nuovi, in grado di dare risposte alle istanze e complessità di un mondo in rapidissima trasformazione, e che davanti ad ogni necessità di cambiamento i porporati e presbiteri reagissero rallentando la locomotiva al punto di dubitare si fosse mai mossa, lo aveva accettato. Ma comprendeva altrettanto chi invece non vi si rassegnava. Era propenso a ritenere che le molte anime che nella sua vita aveva incontrato, e che avevano mostrato sofferenza nell’obbedire ai propri pastori, fossero uno dei volti della Provvidenza, il cui ruolo era incalzare i preti quando diventavano troppo teorici e petulanti. Piero tuttavia era un problema persino in questa nuova collocazione: un provocatore autentico, un cane sciolto da qualsiasi corda, comprese quelle più lente. Don Patrizio lo stimava tanto, e avrebbe voluto portarselo dietro in tutti gli aspetti della vita sacerdotale, perché era un mastino che non avrebbe cessato di mordere qualsiasi ganascia. Il fatto di averci rinunciato per obbedienza era stato un sacrificio accettato con fatica (come ogni vero sacrificio, si risolveva). Un ulteriore elemento di fastidio era stato poi scoprire un Giuda nel luogo dove operava. Qualcuno – ma chi? – il quale non aveva sentito l’esigenza di venire da lui, e dirgli cosa pensava del suo modo di fare il prete e il parroco, e aveva preferito andare a spargere il proprio veleno sotto gli alti soffitti dell’arcivescovado. Una cosa, questa sì, che lo aveva angustiato a lungo, considerandolo come un dispetto personale piuttosto che una divergenza di natura pastorale, sempre possibile. Ma tant’era, e alla fine s’era adattato alle disposizioni calate da quelle stanze. Ora però era tornato sui propri passi, pur non volendo creare un nuovo “caso”, perché riteneva quell’intervento fondamentale. Specificamente, per il gruppo di fidanzati che negli ultimi sei mesi aveva seguito; ragazzi che gli erano sembrati tanto approssimativi relativamente agli aspetti personali del passo che stavano per compiere, quanto parevano pericolosamente rigidi quanto a quelli formali. Un cocktail assai pericoloso. Occorreva una terapia d’urto quale solo Piero avrebbe potuto. E Piero era venuto.
“Vecchio miscredente, canaglia di un’anima randagia, come stai?”
“Io? Molto bene, come sempre. Tu invece mi sembri imbolsito come un cavallo da tiro pronto per il macello. Hai perso qualche altro ettaro di chioma, e ti sei arrotondato ancora. Quante volte te lo devo dire che la verginità non ti fa bene?”
“Tu invece stai uno splendore.”
“Sono solo uno splendido cinquantenne, che sta lottando contro le leggi dell’entropia da un lato, e contro la propria naturale disposizione al narcisismo. Ma devo dire che il quadro che ne sta emergendo non mi dispiace affatto. Dunque, caro amico, come mai?”
“Come mai cosa?”, rispose il presbitero fingendo di non avere capito.
“Come mai hai deciso di rischiare la garrota dell’Inquisizione per portare qui un eretico?”
Don Patrizio attese un po’ prima di rispondere, doveva pesare accuratamente le parole. Una minima spiegazione gli andava pur data, ma in modo da non esacerbare vecchie ferite.
“Intanto, se non ti dispiace, potremmo incamminarci?”, disse allargando le braccia in un invito, “I ragazzi stanno arrivando con le pizze.”
“Suvvia, non fare il misterioso.”, lo incalzò Piero accettando il braccetto che l’altro gli porgeva.
“Sei tu che ti aspetti un mistero dove non ce n’è alcuno.”, fece don Patrizio con tono pacato, “È solo che quest’anno mi sono ritrovato un gruppo di fidanzati un po’, un po’…”
“Un po’ bigotti?”
Don Patrizio guardò Piero con ammirato stupore e gratitudine per avergli evitato d’essere troppo diretto, e preoccupato da ciò che ne sarebbe sortito.
“Non guardarmi così, che mi imbarazzi.”, esagerò Piero, “Non è che ci volesse poi un grande intuito. Uno come me mica lo fai venire per fare una testimonianza rassicurante, e mica puoi non avere messo nel conto di bisticciare col tuo vescovo se non per qualcosa che ritieni importante.”
Aveva capito ogni cosa. Don Patrizio si vergognò per non avere condiviso le proprie preoccupazioni con un amico che si dimostrava così sintonico.
Giunsero al parcheggio. Alle spalle della Toyota di Piero stazionava una Kangoo bianca, coi vetri oscurati dove un coccodrillo verde stilizzato nell’addentare soddisfatto un grosso trancio di pizza, si piegava a formare la prima “C” di “Croccopizza”. Il motore era ancora acceso, incutendo uno strano senso di precarietà al sacerdote. C’era poco tempo:
“Ascolta Piero”, disse voltandosi con una espressione che lasciava trapelare la sua preoccupazione, “in effetti qualche problema quest’anno l’ho incontrato. Non saprei dirti se si tratti di un approccio ideologico; diciamo che durante tutto il corso ho avvertito una sensazione di … soffocamento.” Era soddisfatto dell’uso della parola, perché diceva tutto senza portare materassi sulla barricata di una guerra di religione, ”Ecco sì, una asfissia…”, suggellò il concetto.
Piero scrutò severo nel volto dell’amico per cogliervi un cenno, qualche ulteriore indizio e comprendere a cosa fosse da addebitare il fastidio.
“Don Patrizio sono arrivate le pizze.”, un giovane li interruppe, senza nemmeno il sentore di avere recato un danno, per dichiarare una cosa ovvia.
“Riccardo…”, disse don Patrizio traendo il giovane affettuosamente a sé, “Ricky è la nostra roccia. Non so proprio come faremmo senza di lui. Ebbene, anche Riccardo ha deciso di sposarsi. E io che lo vedevo bene al posto mio tra qualche anno.”
“Ci avevo pensato pure io. Ma poi la chiesa ha nicchiato troppo a cambiare la regola della castità per i sacerdoti, e allora mi son rassegnato a prendere una strada diversa. Farò del mio meglio per servire il Signore anche da sposato.”, il giovane fece stiracchiare un sorriso a Piero.
“Non è una regola, ma un voto.”, finse pignoleria don Patrizio.
“Oh sarà per questo allora che ho sempre avuto voti bassi, fin dalle medie.”
“Testaccia vuota che sei!”, gli replicò don Patrizio frizionandogli affettuosamente la nuca. Docile Riccardo si sottopose al gesto che non doveva essergli nuovo. In lui tutto emanava bontà, in misura direttamente proporzionale a quanto il suo aspetto fosse sciatto e ordinario.
“Oh ma ancora non vi ho presentati. Riccardo lui è il mio amico Piero.”
Riccardo protese la mano destra verso il nuovo arrivato, il quale rispose al saluto indugiando un po’.
“Sì don, ci hai già fatto una testa così, di come stravedi per lui.”, fece Riccardo senza cogliere la freddezza, “Ora è meglio sbrigarsi, prima che gli altri mangino le gambe dei tavoli.”
Quando si fu allontanato don Patrizio lasciò che il suo sguardo si spegnesse sui gesti ripetitivi e sicuri del parrocchiano.
“Riccardo è davvero un ragazzo d’oro.”
“Non ne dubito.”, rispose Piero senza voltarsi.
“Ed è buono come il pane.”
“Si vede da lontano.”
“E allora perché ti sta sul cazzo?”
Piero guardò il sacerdote con aria sorpresa:
“Non ti posso nascondere nulla…”
“Sai, non è che tu abbia fatto poi molto per nascondermi qualcosa. Anzi…”, don Patrizio mise una mano sulla spalla all’amico, “Diciamo che ti si apprezza per tutta una lunga serie di doti, ma il tatto e la discrezione non sono nell’elenco.”
Piero finse di non raccogliere le ultime parole; tuttavia gli partì un sorrisetto compiaciuto. Seguì ancora con gli occhi Riccardo il quale intanto aveva estratto dalla tasca posteriore sinistra un portafoglio logoro, di nylon azzurro, e ne aveva estratto un paio di banconote e una quantità di monetine bronzee, per poi contarle sulla mano del fattorino spazientito.
“Non ti so dire il perché, ma appartiene a quel genere di persone che mi danno una sensazione… di rigetto, come se qualcosa di loro si fosse bloccato in un punto della loro storia senza che se ne accorgessero.”
“Ma come Piero? Ti conosco da una vita, e io so tu pensi che tutti quanti abbiamo subito un ictus dell’anima e conseguente paresi.”, don Patrizio piantò gli occhi in quelli dell’amico.
“Vero! È che nelle persone come Riccardo questo è osceno e palese. Almeno per me. Ma vai a sapere quali siano i motivi inconsci…”, rispose Piero che non doveva aspettarsi un’osservazione tanto pertinente.
“Sarà anche paralizzato, ma intanto ha trovato la fidanzata…”, disse il presbitero forzando l’aggiudicazione di un punto controverso.
Intanto il fattorino, consegnate le scatole con le pizze a due ragazze, aveva guardato più volte la paccottiglia – senza una parte destinata alla mancia che riteneva di meritare – con disgusto; poi era risalito sul furgone di Croccopizza e se n’era andato lasciando una persistente scia di gasolio incombusto. Lo guardavano ancora quando, accesi gli stop per interminabili secondi, aveva svoltato a destra immettendosi sulla provinciale.
“Dieci a uno che non gliel’ha ancora data. Anzi, è stato lui a non chiederla; o peggio a rifiutarla. E sono pronto a scommettere che lei si chiama Simonetta, o Maria Eugenia, porta i capelli raccolti in una crocchia, ha gli occhiali spessi e ride in modo raccapricciante mostrando la gengiva superiore.”
Don Patrizio estrasse il pacchetto floscio di Pall cercando di farne emergere una delle sigarette superstiti – un pacchetto durava sempre meno – picchiando l’involucro con l’indice e il pollice usati come da ragazzino, al mare con l’oratorio, quando spingeva le biglie leggere con un emisfero colorato e l’altro opaco dove si intravedevano le foto di ciclisti irriconoscibili. Le gare duravano una eternità e non vinceva mai nessuno. Certo non lui che si rivelava goffo anche in gestualità talmente semplici. Ma non importava. Il momento più emozionante era la preparazione del circuito, quando a turno si posavano le chiappe a terra e ci si faceva trascinare da due amici per i talloni; il culmine era terminata l’opera, quando ci si fermava a guardare orgogliosi il risultato, la prima gittata di un ponte che univa i continenti dell’immaginazione e della prosa stolida. Gesti antichi e rituali, che si concludevano con una necessaria abluzione in mare per togliere la sabbia dal costume, posseduti dal demone della stupidera. Quello era stato anche l’unico momento della vita di Patrizio in cui le rotondità del suo corpo, che il tempo avrebbe confermato, erano state invidiate dagli amici longilinei, perché “con quel culo” le piste diventavano autostrade. Poi le biglie erano state dimenticate nelle borse del mare incassate sul fondo degli scaffali in cantina e gli amici avevano viaggiato verso nuovi orizzonti, dove invece le sue forme, generose quanto il cuore, si erano rivelate zavorre. Era stato anche il momento in cui aveva scoperto le sigarette e quel gesto avido nella ricerca. Ecco due costanti nella vita di don Patrizio, gli oratori e le sigarette. Oltre al culone ovviamente.
“Ci hai provato. Bel tentativo, ma niente da fare…”
Piero guardò corrucciato l’amico.
“Credevi che ci sarei cascato?”Don Patrizio parlava tenendo lo sguardo rivolto alla desolante sterilità nel pacchetto, “Tentare di violare il segreto confessionale, carpire i segreti che i miei parrocchiani rivelano nel sacramento della penitenza, facendo leva su una scommessa? Ma io ti conosco, mascherina.” Sorrise mestamente.
“Siamo già arrivati a questo? Invochi già il segreto professionale? Tutto facile per voi preti; ogni volta vi si mette alle strette la buttate in angolo una volta per un dogma, un’altra per il rispetto dei vostri codici deontologici.”, rispose Piero restituendo in un colpo il sorriso e lo scherzo.
“Che poi, mi sai dire perché per uno della tua condizione può fumare come una ciminiera senza incorrere negli strali del Vaticano, mentre se lo trovassero a letto con una donna come minimo lo sospenderebbero a divinis? Questa è una delle cose che non tollero della tua chiesa… Converrai che una bella scopata sia meno contro-natura che inondare il proprio sistema cardiorespiratorio di merda e catrame.”
Il sacerdote non avrebbe risposto. Gli sguardi si incrociarono nuovamente, quando il prete trasse l’amico per il gomito in un modo vagamente ansioso:
“Ascolta Piero, non chiederei di meglio di farmi trascinare in una delle nostre dispute infinite, ma non c’è tempo.”
“Dai sputa il rospo…”
“Ovviamente non posso dirti nulla rispetto agli argomenti che toccherai.”
“Ovviamente…”
“Ti chiedo solo di andarci piano. Ma anche su questo temo di non poter fare troppo conto.”
Don Patrizio fece una piccola pausa per lasciare al suo interlocutore lo spazio per una apertura. Che non arrivò.
“E non intendo dirti nulla di preciso riguardo alle persone che fanno parte del mio corso per fidanzati. Ne prenderai coscienza da solo. Sappi solo che sono ragazzi con sensibilità diverse e storie diverse,..”
“Avevo il sospetto che le storie delle persone fossero tutte identiche. Per fortuna mi hai fermato in tempo.”, Piero fece una di quelle facce da schiaffi che mandavano in bestia l’amico ogni volta.
“Piantala di fare il coglione!”, fece spazientito il sacerdote, “Ascolta, io sono davvero preoccupato, perché questo gruppo è davvero molto eterogeneo, insomma… vedo alcuni approcciarsi al sacramento in modo estremamente ideologico, altri farlo con approssimazione e ingenuità, altri ancora un po’, un po’…”
“Manipolati?”
“Non è la parola che avrei usato io…”
“Allora è la parola giusta.”, Piero sfoderò un altro sorriso beffardo, senza riuscire tuttavia a togliere il velo opaco, calato sul volto del prete.
“Credo di avere capito. Dimmi solo un’ultima cosa: chi hai invitato a mostrare le virtù e delizie del matrimonio religioso?”
“Io invito soltanto degli amici a portare la propria testimonianza. A parte questo, il mese scorso sono venuti i Murato.”
“Non ci posso credere, il Gianni Murato, e Isabella… sono ancora vivi?”
“Se non è successo qualcosa di terribile nell’ultimo mese, suppongo di sì.”
“L’inossidabile Gianni Murato, portatore sano e inconsapevole del virus della ingenuità matrimoniale. Letale. Dai, che ho capito cosa ti occorre. Andiamo che ho un po’ di fame?”
Ma ancora don Patrizio non si mosse, aggrappandosi invece al gomito:
“Per favore vacci piano!”, disse fissandolo nuovamente negli occhi.
Piero stavolta ne fu infastidito, si divincolò dalla presa:
“Se volevi uno che usassi il guanto di velluto, avresti cercato me? Io farò come mi verrà spontaneo fare. Però facciamo sempre a tempo a cambiare idea, e non entro nemmeno e la pizza me la mangio da solo in un locale. Decidi tu.”
Don Patrizio emise un lungo sospiro, poi spinse nuovamente l’amico.
“Dai, andiamo”.
Oltrepassarono a grandi passi lo spazio che lì divideva dal gruppo, nel frattempo ingrossato. A dirigere le operazioni sempre Riccardo che con dedizione stava disponendo due a due le esili sedie bianche da giardino precedentemente estratte dalla pila di Alberto. Quando ebbe quasi finito il giro con aria pensierosa guardò don Patrizio e disse “per te ci vorrà tripla. Mica vorrai finire lungo e disteso per terra?”
“Fai sempre il pirla tu, che alla fine vedrai come ti firmo l’attestato. “, rispose don Patrizio.
Piero non seguiva il siparietto e si mise a scrutare le persone con cui si sarebbe confrontato quella sera, e ne confermò la sensazione urticante; grossomodo erano una ventina, ma non avrebbe però potuto qualificarli come “giovani” perché in cinque o sei avevano passato da tempo i trenta. Quasi tutti cercavano di rendersi utili per distribuire piatti e posate, ma in molti giravano a vuoto. Fatta eccezione per Riccardo, la più operativa era una ragazza concentrata nell’aprire i cartoni fumanti e sezionare gli spicchi di pizza, depositandoli con fare esperto nei piatti di plastica, che subito si flettevano per il peso e il calore. Una bella ragazza, non troppo alta e con forme generose, aveva occhi nocciola e capelli biondo cenerino non troppo lunghi tagliati in modo regolare che si fermavano prima di toccare le spalle. Indossava una polo ed un paio di jeans scuri, suggerendo tuttavia l’idea di un meticoloso studio nell’abbinamento di indumenti casual, che casuali lo erano pertanto molto poco. Piero la detestò subito, più di quanto non fosse disponibile a riconsiderare la propria posizione relativamente a Riccardo. Dietro a una maschera di mansuetudine, si agitava una ferocia spaventosa; aveva l’aria determinata di chi sa esattamente dove vuole arrivare, che si tratti di tagliare una pizza, sposare un gonzo o scalzare un collega in banca – perché dal primo istante seppe che lavorava in banca -, per fare carriera. Cristo! Le fette erano talmente precise da sembrare tagliate meccanicamente. Durante il lavoro non sorrise mai, un altro indizio sgradevole. A un tratto giunse un giovane alle sue spalle, che le pose le mani sui lombi sussurrandole qualcosa. Lei rispose senza girarsi: un bellissimo ragazzo, con tanto di fluenti capelli neri raccolti in una coda di cavallo, orecchino e camicione largo aperto e una T-shirt aderente. Dai bottoni aperti emergevano le rune grinzose di ZoSo, il logo dei Led Zeppelin – proprio uno sballone teletrasportato direttamente dagli anni ’80 – più idoneo per un collettivo di extraparlamentari, a rollarsi una canna, oppure a incidere simboli anarchici sulle pareti della metropolitana piuttosto che in oratorio. Il volto dello sballone era contornato da un accenno lanuginoso di barba non rasata, che si accordava alla perfezione con il sorriso sincero e gli occhi scuri profondi.
“Che spreco!”, pensò Piero scuotendo il capo per la delusione mentre la bancaria assegnava al fidanzato due piatti debordanti di mozzarella fusa.
Individuò quasi subito l’imminente sposa di Riccardo, una ragazza alta e ordinaria, tuttavia molto più graziosa di quello che aveva sospettato. Un uomo sulla quarantina sostava impacciato ai margini del quadretto, seduto su una panca vicino alla grande finestra che dava sul campo di basket, esitante tra il non rendersi ridicolo e attestare pubblicamente la propria inadeguatezza. Aveva occhi scialbi, rassegnati sotto una fronte ampia da contabile o impiegato di concetto: “Amministratore condominiale!”, si compiacque Piero, pur senza poter verificare la supposizione. I capelli radi e corti, un rossiccio insignificante, denunciavano una sconfitta contro la calvizie avvenuta molti anni prima. I pantaloni beige facevano parte sicuramente di un completo, con la giacca lasciata non senza esitazioni a casa. Un gilet azzurro e la camicia chiara, con sottili righe verticali rosse, sancivano il discutibile compromesso tra formale e informalità. Qual era la fidanzata? Lo scoprì con un moto involontario di orrore poco dopo: gonna lunga oltre il ginocchio, polpacci da decatleta, camicia abbottonata sino ad avvolgere il collo, volto senza intelligenza e acconciatura anni ’70, da testimonial sull’uso di prodotti a base di glutammato di sodio. Fu colpito invece da una ragazza bassa e rotondetta, che sprigionava energia ovunque. Aveva capelli a caschetto, colore del mosto, ed elargiva parole gentili a chiunque le si avvicinasse. Ma gli sforzi volti a individuare il fidanzato si rivelarono inefficaci. Certamente non doveva essere una relazione appiccicosa, e anche questo gli piacque. Il gioco delle coppie lo divertì ancora qualche minuto. Quando si sedettero al tavolo, don Patrizio lo venne a cercare per una forma di controllo, l’ultima, e gli si sedette accanto.
“Don Patrizio, non ci fai dire una prece?”
Al solito Riccardo compensava con genuino zelo ai compiti nei quali il sacerdote risultava approssimativo. Don Patrizio lo guardò senza benevolenza. Gli accadeva abbastanza spesso di commettere omissioni simili, ma riconoscere quel tipo di debito gli riusciva più arduo della dimenticanza che l’aveva generato.
Fattosi austero, il prete recitò brevemente un gloria, invitando con una gestualità approssimativa a fare altrettanto gli altri. Vi si sottoposero tutti, eccetto Piero e lo sballone, che guadagnò così un altro punto. Poi dopo avere trangugiato un boccone di pizza troppo abbondante per passare inosservato, don Patrizio stabilì che era arrivato il momento di fare le presentazioni:
“Allora ragazzi, vi presento il mio amico dei tempi dell’università Piero Oldini, che di mestiere fa l’ingegnere civile. Ma si diletta anche di architettura, filosofia, psicologia e Dio sa quante altre cose. Loro sono Marco e Stefania…”, don Patrizio divaricò due dita ad indicare lo sballone e la bionda. Riccardo già lo conosci, e Cinzia è la sua fidanzata. Poi venne il turno di Ambra, Marcello, una seconda Cinzia, e Gianluca. Ma Piero non lì registrò neppure, mentre scoprì che la ragazza rotondetta e simpatica si chiamava Giulia, e che quella sera era single perché Mauro, il fidanzato, era in viaggio di lavoro. Mentre lo dichiarava era rassegnata, come se i suoi compagni di corso dovessero esserci abituati; Piero se ne dispiacque. Infine rinnovò il ribrezzo quando scoprì che il commercialista si chiamava Fulvio e il mostro che avrebbe impalmato Crina, un’infermiera moldava incontrata in chissà quale tunnel della solitudine.
La cena procedeva senza particolari intoppi, con don Patrizio che elargiva le proprie attenzioni ora ai ragazzi, ora a Piero, procrastinando ancora il momento del confronto. La pizza, da tempo fredda, non consentiva di verificare fosse stata croccante quanto il l’insegna aziendale ammiccava; tuttavia si rivelava un discreto espediente per soddisfare gli appetiti e predisporre i cuori a raccogliere qualcosa. Don Patrizio avrebbe volentieri fatto un bis, ma temeva la disapprovazione dei parrocchiani, troppo attenti ai suoi peccati. L’indesiderata attenzione cui si sentiva fatto oggetto lo fece grugnire insoddisfatto davanti al piatto vuoto – gli altri si trovavano ancora a metà percorso -, rivolto a un interlocutore invisibile, il cui rimprovero gli pesava più di quanto non avrebbe mai ammesso. Prima che potesse elaborare l’antidoto per un veleno che gli era stato inoculato dal senso di colpa, Marco richiamò la sua attenzione:
“Ehi don, posso dirti una cosa?”
Il prete gli rispose uno sguardo pingue. Era parzialmente sintonizzato.
“Volevo ringraziarti per la volta scorsa…”, si fermò per valutare bene le parole, “… cioè sono sicuro che l’ospite che hai portato questa settimana ci dirà dose molto interessanti, ma volevo tornare per un secondo all’incontro del mese scorso; sì quello con Gianni e…?”
“Isabella.”, lo soccorse Stefania che sfruttò la pausa per ghermire le nocche del fidanzato, innescando un meccanismo di repulsione tanto in Piero quanto nel prete.
“Giusto, Isabella!”, continuò lo sballone mentre si lasciava invadere dalle dita di lei, “ecco volevo ringraziarti per averli portati qui, perché… non so gli altri, ma io e Stefania ne abbiamo parlato a lungo, e credo di avere capito qualcosa di importante.”
“Sono tutto orecchi…”, disse il prete allertato per la quota di responsabilità che stava per emergere. Era meno convinto che ne sarebbe venuto qualcosa di buono.
“Beh, tu sai la mia storia, e come sono arrivato qui.”
A Piero sembrò di vedere l’ombra di un ghigno fugace dipingersi sul volto della fidanzata, come un cacciatore sotto la testa di un trofeo.
“Non sono mai stato uno ‘da oratorio’…”, di nuovo si guardò intorno per verificare che le parole non causassero disagio, “Insomma, qui non ci sarei mai arrivato se non fosse stato per Stefania.”
Le falangine e falangette erano bianche come l’intonaco per la mancata irrorazione dei capillari a causa della morsa cui erano sottoposte.
“… e quando sono arrivato in questo luogo ero molto scettico, lo ritenevo più che altro un favore che dovessi fare a lei, ma di cui non mi importava nulla. A me sarebbero andate benissimo anche la convivenza, o il matrimonio civile, solo che lei ci teneva – ci tiene – così tanto, e quindi mi sono sottoposto malgrado tutto al ‘supplizio’…”
Con un sorriso cerco un po’ di accondiscendenza, che Piero e don Patrizio non gli negarono (se non altro per l’anemia del metacarpo). Un po’ meno gli altri.
“Per farla breve, qui ci sono venuto sempre – quando mi assumo un impegno intendo onorarlo fino in fondo -.”, questa volta Stefania non ce la fece a nascondere l’espressione di fiera conquistatrice, “Ma le cose che hanno detto Gianni e Isabella, mi hanno toccato profondamente. Mi hanno fatto capire cosa sia il matrimonio per Stefania, e perché sia così importante che avvenga in chiesa e non in un altro luogo. Per loro non si tratta di un fatto istintivo, non un capriccio, ma una scelta e un impegno preso davanti a Dio, nel quale era Dio stesso a impegnarsi con loro…”
“E per loro…”, don Patrizio si morse la lingua, che non ce l’aveva fatta a evitare affiorasse il suo lato curiale – come lo definiva egli stesso con disprezzo -. Avrebbe voluto pensarci un po’ prima di avallare il ragionamento, e invece aveva scelto l’eleganza della prosa al valore dei contenuti. Ma era troppo tardi. Che testa di prete!
“Giusto, giusto: ‘per’ loro, per portare a compimento la loro scelta. Insomma… quei due si amavano ancora, dopo quanti…?”
“Quaranta.”, lo redarguì come una maestrina Stefania.
“Quaranta anni, e ho capito – Stefania mi ha aiutato – che non sarebbe stato possibile se non in un luogo come questo.”
Fece una pausa giusto prima di tirare le somme.
“Io non ho ancora capito cosa ci trovino le persone nella chiesa, e di religione non capisco un ca… non capisco niente, ma due cose le ho afferrate: la prima che l’amore è un Mistero, e che Dio è un Mistero. E siccome io amo davvero Stefania, e voglio dividere la mia vita con lei, è un gioco che devo…, che voglio fare a questo tavolo.”
Stefania era talmente compiaciuta da non poter più nascondersi, e mentre gli ghigliottinava le dita, guardò il fidanzato con l’entusiasmo di un broker che vede esplodere le azioni di una compagnia sostenuta contro l’opinione di tutti.
Don Patrizio invece lo fissò con uno sguardo in cui contrastavano un’ammirazione corposa e la percezione di un misfatto imminente. Ma, nella sua veste, cosa avrebbe potuto fare? Si sentì inerme per quel destino beffardo.
“Peccato!”
“Scusi?”, Marco guardava Piero come se stesse osservando un elefante che atterrava con un paracadute. La fidanzata, esterrefatta, per un istante mollò la presa, lasciando che il proprietario prendesse coscienza dei polpastrelli attraverso un formicolio, quando il sangue vi refluì.
“Beh intanto diamoci del tu, se sei d’accordo.”, disse Piero, “Altrimenti sarò costretto a usare anche io un linguaggio formale, e ne faccio volentieri a meno.”
Marco annuì attonito mentre l’elefante ripiegava ordinatamente il paracadute.
“Per il resto intendevo solamente dire ‘peccato tu sia arrivato a questa conclusione’. Tutto qui.”
“Mi scusi ma lei, tu… non sei d’accordo?”
Stefania era uscita dal torpore dell’estasi e si era attorcigliata come una vipera dopo lo scoperchiamento della pietra sotto la quale riposava.
“Beh, potrei non avere un lessico particolarmente ampio, ma garantisco che se fossi stato in sintonia, avrei usato parole diverse.”
Con gli occhi pieni di inimicizia la ragazza prese a squadrare Piero con cui presto si sarebbe misurata. Su questo non c’era dubbio. Intanto prese a sollecitare i palmi delle mani del fidanzato. Lui però, ripreso inaspettatamente possesso dell’estremità, inventò un gesto che la richiedeva altrove:
“Ti puoi spiegare meglio?”
“Ci posso provare. Diciamo che io sostengo che il matrimonio sia la tomba dell’amore, e che se si scopre il caso eccezionale – conosco Gianni e Isabella e ne hanno tutti i crismi – non debba andare a incidere sulla consapevolezza della regola.”
“Non capisco…”, disse l’altro imbambolato, mentre guardava l’elefante mettersi in coda per risalire sull’aereo ed effettuare un nuovo lancio.
Questa volta fu Piero a tormentarsi con la destra il collo.
“Tu ad esempio, cosa fai nella vita?”
“Cosa studio?”
“Se studi…”
“Medicina, ultimo anno.”
“Ecco, perfetto. Tu credi nei miracoli di Lourdes?”
“Boh non ci ho mai pensato…”
“Allora immagina di essere nei panni del medico/futuro Nobel Alexis Carrel, che all’inizio del ventesimo secolo segue un gruppo di malati gravissimi a Lourdes. Lui è scettico oltre ogni misura, e in particolare osserva una donna malata terminale. E’ certo ne abbia per pochi giorni. Ci sei Marco?”
“Sì, credo.”
“A un certo punto, davanti alla Grotta, lui vede coi suoi occhi scettici la malata riaversi. E come medico registra la sua guarigione. Questo racconta nelle sue memorie. Ora, se tu fossi nei suoi panni riconosceresti essere di fronte a una ‘guarigione misteriosa’, quantomeno in sintonia con la parola mistero che hai appena usato?”
“Beh, immagino di sì.”
“Perfetto! Ora, sempre restando nei suoi panni, una volta tornato da Lourdes, ai malati di neoplasie, prescriveresti la chemioterapia o una flebo di acqua di Lourdes?”
“Certamente la chemio, ma che c’entra?”
“C’entra eccome. Tu un mese fa hai assistito a un miracolo. Arrivare alla tua conclusione è come essere malati di cancro, e rinunciare alla medicina per fare lavande con l’acqua del Gave.”
Questa volta l’elefante si dissolse, e il ragionamento sembrò toccare un punto remoto del ragazzo.
Stefania non poteva accettarlo.
“Mi scusi, ma se lei crede così poco nel matrimonio, cosa ci fa in un corso per fidanzati?”
“Questa è una ottima domanda, ma l’interlocutore è sbagliato: dovresti farla a don Patrizio.” Quaranta occhi si voltarono sul presbitero.
Questi, che fino ad allora aveva seguito tutti gli incroci come un arbitro di tennis, si sentì afferrato da un pugno invisibile e piazzato al centro del campo di terra rossa. Non gli piacque. Soprattutto non gli piaceva dover dire qualcosa di utile senza correre il rischio di scandalizzare qualcuno.
“Ho invitato Piero in quanto ritengo che il passo che voi tutti state per fare, richieda un livello di consapevolezza che include anche gli aspetti più controversi del matrimonio, per il semplice fatto che esistono…”
Si fermò a osservare se il contrafforte frettolosamente costruito reggesse. Reggeva.
“Io sono d’accordo al 100% con le considerazioni fatte da Marco prima, e Gianni e isabella, in fondo li ho invitati sempre io.”, rivendicò non senza una punta di orgoglio, “Ma credo anche che per una scelta come la vostra possa essere utile mettere un po’ di pepe sulla tavola, e mi pare che Piero sia proprio la persona giusta.”
Sarebbe stato sufficiente per dissimulare tutta quella attenzione? Però cazzo, l’analogia col pepe faceva pena…
“Credo che appartenga ai miei compiti farvi conoscere quali siano gli aspetti di fatica del matrimonio non meno di quelli più gratificanti, e sarei un cattivo pastore se li avessi nascosti. Reputo un mio dovere aiutarvi a comprendere che non saranno solo ‘rose e fiori’, e che ci saranno molte più difficoltà di quello che adesso immaginate. Ai miei corsi per i fidanzati dico sempre che sbagliano a pensare troppo al giorno della cerimonia, perché quello è solo l’inizio delle fatiche e delle responsabilità. Perciò abbiate pazienza ma credo che Piero sia davvero un testimone importante da ascoltare oggi.”
E che cazzo! Doveva dirlo e l’aveva detto. Scoprì in quel momento la gratificazione dell’orgoglio per quanto fosse piacevole armeggiare lo stiletto del puntiglio. Dopo se ne sarebbe pentito, e avrebbe riformulato una professione di umiltà. Dopo, però.
Per confermare gli astanti nella sincerità dei suoi voti e dei suoi intenti, si pose le mani sull’ampio ventre come quando si allenava a fare il vescovo. Quel movimento, oltre alla schiettezza che aveva appena infuso nelle parole, confortarono le anime dei fidanzati, che tornarono a guardare le mosse di Piero lasciando prevalesse la curiosità sull’ostilità iniziale. Non Stefania, però.
“Beh certo! Per un cinico non ci vuole nulla per venire qui a sparare a 0 sull’amore. È più facile distruggere che costruire.”, nelle parole delle giovane era vivida una fiamma di ferocia
“Probabilmente non mi sono ancora spiegato bene: non ho niente contro l’amore, ma ho molto da dire contro il matrimonio, che è…”
“La tomba dell’amore.”
“Già…”
Stefania tornò a tacere – sospendendo la tortura inferta alle dita del fidanzato -, limitandosi a serrare le labbra e incrociare le braccia sotto al seno rigoglioso. Piero si perse per un istante a pensare che fosse un ottimo avversario, e possedeva un fascino magnetico che da lì in poi non avrebbe più sottovalutato. Non c’era da stupirsi quali fossero le arti attraverso cui aveva accalappiato un personaggio decontestualizzato come Marco.
“Ma perché? Non capisco…”
Era stata Giulia a solidificare la domanda di tutti. In lei non c’era la strategia di Stefania, ma una curiosità amareggiata.
“Intanto esistono delle statistiche molto precise, che sarebbe un errore non considerare. Solo venti anni fa la somma delle separazioni e dei divorzi raggiungeva appena il 25% del totale! mentre oggi superano la metà. I matrimoni religiosi allora erano quasi i 4/5 e ora solo i 2/3. Perciò si potrebbe quantomeno rilevare che non sono stato l’unico a pensarla così, e per quello che ne so io di voi – ovvero nulla – perché dovrei pensare usciate dalla statistica? Perciò vi sposerete, due coppie si separeranno entro i primi cinque anni, altre tre o quattro entro i quindici. E di quelli che non divorzieranno, molte vivranno il proprio essere sposati come un calvario, e solo se fossi estremamente fortunato mi troverei di fronte alla possibilità di vedere, tra quarant’anni, la versione due punto zero di ‘Gianni & Isabella’. Ma francamente ne dubito.”
Ciò detto Piero si fermò a sfidare i suoi interlocutori. Il guanto fu subito raccolto.
“Per essere uno che non ci conosce per niente, ne dici di cose…”, Giulia era risentita.
“Viviamo anche noi in questo mondo, e le statistiche le conosciamo, se non altro per averle osservate proprio qui. Ma che c’è di male a desiderare di stare accanto alla persona amata tutta la vita?”, disse un disarmato Riccardo.
“Non si tratta di cosa si desidera, ma di cosa si raccoglie. E soprattutto cosa si sta per seminare.”, rispose
“Ma non capite?”, Stefania, parlava come un ventriloquo, senza disimpegnare la postura ostile, “Questa volta don Patrizio – scusa don, ti voglio bene, ma te lo devo dire – ha fatto una cazzata. Probabilmente voleva invitare qualcuno che avesse qualcosa di interessante da dire, ma alla fine ha trascinato qui un rudere, figlio del cinismo, della disillusione e del disincanto e che vorrebbe versare un po’ di veleno su di noi.”; anche Marco guardò la fidanzata con stupore, poiché non conosceva tanta durezza, o forse la percepiva senza averla mai effettivamente considerata.
Gli altri tuttavia sembravano riconoscersi nelle parole. Persino Fulvio e Crina, fino lì avulsi, approvarono la mossa con larghi cenni del volto.
Anche Piero sentì la stoccata, e non fece nulla per dissimulare:
“Deluso io? Sì, direi proprio di sì. Potrei avere le mie buone ragioni però…”
Che tenerezza! Don Patrizio, che conosceva la vulnerabilità sotto la scorza dell’amico. Doveva fare qualcosa:
“Sei ingiusta Stefania, Piero è un amico, e potrà dire le sue argomentazioni forse sgradevoli, usando argomenti in modo che magari non condivido, ma – e rispondo anche a Giulia – non ha detto nulla che potesse realmente offendere. Perciò rinnovo il mio invito a raccogliere le provocazioni, senza tuttavia personalizzarle.”
Stefania percepì di avere superato una linea invisibile, ma non venne meno a una delle sue regole fondamentali: mai, mai scusarsi, in nessun caso! Persino contro ogni evidenza, figurarsi se sapeva d’aver ragione così palesemente. Continuo piuttosto a guardare Piero preparando un nuovo contrattacco, arroccandosi ancora dietro al petto spavaldo e alla sua bellezza prorompente, che il rancore stava esasperando.
“Io invece vi invito a personalizzare se questo è il vostro modo di elaborare questioni importanti”, disse invece Piero.
(Che stronzo!), se la rise interiormente il sacerdote mentre scuoteva impercettibilmente la testa dopo che l’amico lo aveva spiazzato completamente. Ma c’era abituato.
Il clima tuttavia era cambiato. Il cruento duello, se aveva esacerbato l’animo della bionda Stefania, e toccato duro quello di Piero, aveva visto anche gli altri partecipare più attivamente di quanto non fosse nella loro indole. I piatti di plastica, intasati delle croste di pizza gelida e rinsecchita, giacevano ammonticchiati al centro del grosso tavolo, inerti come i teschi e le clavicole in un ossario. I bicchieri invece continuavano i turni di riempimento e svuotamento, affinché le bibite andassero a governare incendi di pensiero appena attizzati.
(Altroché aranciata), penso il presbitero, (ci vorrebbe il MacAllan invecchiato dodici anni…).
“Ma perché il matrimonio dovrebbe essere la tomba dell’amore?”, ancora fu la trasparenza di Giulia a superare l’impasse, “Cosa non ti convince? Amare non implica una assunzione di responsabilità?”
“Al contrario! È proprio il tema della assunzione di responsabilità che mi fa pensare male del matrimonio.”
“Oh bella! Questa mi giunge proprio nuova…”, fece lei ancora più perplessa, “Mi vorresti spiegare?”
Piero fece una pausa, perché argomentare gli riusciva meno naturale che provocare. Avrebbe preferito “mordere e fuggire” piuttosto che dilungarsi in sillogismi e similitudini, scandalizzare era divertente, convincere noioso. Punto. Però poteva sempre avventurarsi sull’autostrada della logica, e fuoriuscirne per qualche sortita più avanti.
“Vedi, il matrimonio ha molti aspetti, ma mi vorrei soffermare essenzialmente su due, anzi tre, se vogliamo considerare la cerimonia. Il primo è presto detto, ed è che i coniugi dovrebbero amarsi.” – Stefania alla puntualizzazione ebbe un sussulto, ma tacque ancora, un macellaio che affila le lame nel retrobottega – “E un secondo aspetto, che è di tipo formale, giuridico e, se vogliamo, anche sociologico.”
“Cosa intendi dire?”, Marco trepidava.
“Avete presente tutti i ‘donpatrizi’ d’Italia”, – disse proprio ‘donpatrizi’, mentre il sacerdote al fianco gli riservava un sorriso beota e un (chegranfigliodiputtana!), ovviamente solo rimuginato -, “che la domenica dal pulpito riversano le loro litanie sulla crisi degli autentici valori, sulla società dei consumi, delle mezze stagioni che non ci sono più, e della famiglia come principale risorsa in questo mondo che va a pezzi? Ecco, durante quei pippotti, di quale aspetto tra i due elencati la chiesa si farebbe portavoce?”
I fidanzati erano sbalorditi, mentre Don Patrizio, cui il riferimento alle mezze stagioni non era proprio piaciuto, rincarando il cogito “(che grandissimofigliodi…)”
“Su, un po’ di immaginazione creativa…”
“Beh suppongo quello giuridico.”
“Perfetto Riccardo. Vi propongo ora di usare una immagine per descrivere le stesse dimensioni: potremmo paragonare il matrimonio a un grosso pacco regalo, dove la carta da regalo è la cerimonia – più o meno bella o sfarzosa -, le pareti della scatola sono gli aspetti giuridici, e il contenuto è l’amore che due sposi dovrebbero nutrire l’uno per l’altro. Ci siete?”
“Sì…”
“Bene. Io contesto alla chiesa di essersi affannata a difendere la scatola, dimenticando – o peggio, facendo finta di ricordare – il regalo.”
Ecco, la prima scorribanda, che ottenne l’effetto sperato, perché gli occhi dei fidanzatini erano tutti strabuzzati. Lui non si negò il compiacimento.
“E questo cosa c’entra con le responsabilità dei coniugi?”, di nuovo fu Riccardo il primo a riprendersi. Un po’ la cosa seccò a Piero, perché doveva ricominciare dagli aspetti che lo ingolosivano meno.
“Ma come… non è ancora chiaro?”, sbuffò, “Se qualcuno ti fa un bellissimo regalo, tu ti senti vincolato dalla scatola o dal contenuto?”
“Veramente un dono non dovrebbe creare vincoli…”, rispose con avventatezza Stefania, che si protese per un istante verso il suo avversario, ma immediatamente arretrò.
“Perfetto! Bravissima! È proprio così.”
“Secondo me ti stai contraddicendo…”, fece Giulia che per la prima volta sembrò avere perduto la curiosità iniziale.
“Niente affatto. Oppure… sì. Ma per sostenere un paradosso.”
“E quale?”
“Quello dell’amore. Sì, l’amore è un fatto paradossale, e io non perdono alla chiesa di averlo dimenticato.”
“E in cosa consiste il paradosso? Ma soprattutto in quale misura obbliga a una ‘responsabilità’?”, di nuovo lo sballone, la cui inquietudine gli fece riguadagnare i punti perduti quando si era lasciato ghermire dalle chele di Stefania.
“Lo ha già detto la tua fidanzata, forse involontariamente. Non c’è alcun autentico obbligo in un dono, se non dover riconsiderare in ogni momento, che tuo marito o tua moglie – io preferisco dire ‘l’Altro’- non ti deve nulla. Nemmeno un grazie. Per quante liturgie tu abbia celebrato, per quanti riti abbia consumato, o sacramenti scomodato, per quanti interventi divini possa avere invocato, per quanti figli abbiate avuto, anni convissuto, per quanto vorresti fosse solida la scatola, per quanto tu possa avere bisogno di quella scatola, o per quanto possa essere stata bella e costosa la carta da regalo, per quanti anni di mutuo restino da pagare, per quante promesse vi siate scambiati, l’Altro resta un mistero: non è, non è mai stato e non sarà mai ‘tuo’, e la prova ne è che può fare esattamente, e niente altro, ciò che vuole, e se vuole andare via, se ne va. Punto. Assumersi la responsabilità innanzitutto di fronte al tribunale della propria coscienza per tenere duro su questo livello di consapevolezza. E se comporta una ferita, abituarsi a sanguinare. Le responsabilità dell’amore derivano da questa dimensione: amare l’Altro fino ad amare questo.”
Dopo queste affermazioni, nella stanza del ping-pong scese un silenzio fitto come il buio che aveva stabilito la propria iniqua misura fuori la finestra. Gli sguardi erano allibiti. Persino Stefania aveva accantonato un po’ della sua prosopopea, accusando il rinculo, abbandonando le braccia lunghe il corpo. L’unico che se la godeva – senza farlo trapelare naturalmente – era don Patrizio, che riteneva probabilmente raggiunto l’obiettivo della serata. E con un certo anticipo, per giunta. Certo il prezzo era alto, e la moneta con cui pagarlo la bile contro la sua chiesa, che l’incorreggibile Piero non poteva fare a meno di sversare. Ma, se questo era lo scotto perché i ragazzi, che egli realmente amava, potessero imbattersi in una dimensione meno bucolica, un realismo crudo e necessario, lo avrebbe pagato volentieri.
“Che botta!”, disse Riccardo mentre il suo sguardo seguiva la mezzeria bianca del tavolo e ci si perdeva come un autostoppista ubriaco. Lo guardarono con gratitudine per avere disciolto il calcolo di silenzio.
“Scusa Piero, io però ancora non ci sto. So perfettamente che il mio moroso è una persona libera – tanto che qui non c’è… -, ma non mi pare la chiesa mi abbia insegnato a cercare il contrario, o di vincolarlo ai miei capricci per l’eternità. E mi sembra ovvio che se lo sposerò sarà per costruire qualcosa con lui, ma se un giorno se ne dovesse andare, soffrirò, ma non lo inseguirò mica con la mitragliatrice.”, fece Giulia.
“Tu forse no, ma la chiesa?”
“La chiesa cosa?”.
“È la chiesa che parla di indissolubilità del legame coniugale.”
“Ma che c’entra? L’indissolubilità riguarda la natura sacramentale del legame, e la croce non è mica un’ascia da impugnare per costringere gli altri a fare ciò che non vogliono.”
Immensa Giulia! Nel vedere quanto fosse battagliera don Patrizio si sentì gonfiare il petto per l’orgoglio: l’aveva preparata proprio bene. E quasi gli dispiaceva, mentre svuotava l’ennesimo cilindro di carta fradicia dalla spuma rossa, doverle fare il tifo contro, almeno questa volta. Ma il silenzio gli giovava un sacco. Piero prima di rispondere prese a tormentare la pelle grinzosa alla base del collo:
“Sei sicura che esista un solo modo per ‘costringere’ qualcuno a fare qualcosa?”
“Ce ne sono molti? Non sapevo…”, questa volta fu Stefania a non farsi sfuggire l’occasione di un affondo talmente invitante.
“Capisco, eppure è proprio così.”
“E quali sono, di grazia?”
“Cosa succederebbe se io andassi in giro senza scarpe?”
Questa volta anche il prete corrucciò le sopracciglia per lo stupore. Stefania invece fece un ghigno, gustando l’inciampo, come un anticipo di vittoria. Rispose Riccardo, scarno:
“Credo che ti taglieresti, e ti dovremmo portare al pronto soccorso.”
“O magari te prendi una malanno.”, piombò col suo italiano in prova Crina, che temeva le si sottraesse il monopolio dei riferimenti sanitari, raggiunto a duro prezzo. Quelle poche parole furono sufficienti per mostrare le torride gengive violacee, e far inorridire tutti quanti.
“Magari sì, oppure no. Ci sono uomini, popoli interi, che vivono- o hanno vissuto per molto tempo – senza indossare un paio di scarpe e non passavano per questo le proprie giornate a massaggiarsi le piante dei piedi.”
Pausa.
“E magari hanno resistito a lungo alla prospettiva perché ritenevano di ricevere qualcosa a contatto con la terra che una suola in tomaia gli avrebbe precluso.”
“O bella! Sta a vedere che ora critica anche l’industria calzaturiera.”, Stefania assestò un colpo leggero e preciso.
“Non dico questo. Piuttosto se io, questa sera, mi fossi presentato in giacca cravatta, e a piedi nudi, mi sarei garantito quantomeno un certo tipo di sguardi.”
“E quali?”, fece Riccardo.
“Quelli che mi avete appena certificato voi. Di essere una persona con uno scarso senso dell’igiene, a rischio di chissà quali malattie fungine, e molto probabilmente un po’ matto.”
“Più di così? Difficile…”, la battuta di Marco, genuina e affatto maliziosa, strappò una risata ai presenti, con la vistosa eccezione della fidanzata. Però ci voleva: “Ti prego continua… Me l’hai messa lì e non poteva non tirartela.”
“Ecco… cercavo solo di sottolineare una cosa; che tra i motivi per non mettere le scarpe, ci potevano essere eventuali affinità con alcuni popoli non tecnologici…”
“(Non sottovalutare la follia!)”, Marco finse di bisbigliare, provocando una salva di risate soffocate.
“Già la follia. Mentre tra le ragioni per indossarle ci metterei quelle che avete detto voi. Oppure, che non è molto diverso, dispensarmi dallo sguardo che mi avreste riservato.”
“Dove vuoi arrivare?”, domandò Giulia, tradendo un presentimento intrecciato ad un’aspettativa.
“Semplice! Che nessuno di noi è effettivamente libero, se deve confrontarsi con lo sguardo intransigente degli altri.”
“Tu vuoi dire che non siamo realmente liberi perché gli altri intorno si aspettano qualcosa da noi?”
“Ci sei quasi, Giulia”, rispose con un sorriso ammirato, “perché noi vivremo sempre confrontandoci con le altrui aspettative. E’ un principio inamovibile, su cui si fonda l’idea stessa della civiltà.”
“Ah Marcuse, Eros e Civiltà. Per non dire Freud!”, bofonchiò don Patrizio – in modo però che tutti sentissero -. Non lo fece per sé – era sostanzialmente immune da ogni forma di supponenza – ma perché non si affrettassero a tagliar fuori la chiesa da un dibattito talmente importante.
“Esatto, o anche la teoria dei Complessi di Jung”, Piero accettò il contributo, “Siamo diventati adulti in un campo minato, esposti costantemente alle proiezioni e valutazioni dei genitori, i figli più tardi, quelle degli insegnanti, e gli amici, i fidanzati, i mariti o le mogli. Per arrivare a quelle della chiesa e – perché no? – quelle che vengono attribuite a Dio medesimo.”
“Magari alcune di quelle aspettative sono per il nostro bene, così come indossare un paio di scarpe ti ha evitato epidemie di tetano.”, Stefania sferrò il colpo con tempismo perfetto; aveva ancora parecchio veleno da irrorare.
“Può darsi, anzi, diamolo pure per certo. Infatti il problema non è il contenuto di una aspettativa quanto il regime di vincolo.”
Marco era perplesso.
“Non puoi fare qualche esempio?”
Piero aspettò a rispondere: l’esempio ce l’aveva eccome, piuttosto faticava a capacitarsi dei tempi lunghi del purosangue sul quale, in quella particolare scuderia, avrebbe voluto scommettere. Un po’ se ne rammaricò. La frustrazione lo fece accanire contro il bicchiere di carta gocciolante.
“Qualche anno fa avevo un amico…”, poi sembrò ricordarsi di don Patrizio, “Dai, ti ricordi il Fausto Tardioli?”, l’altro annuì, più per consentire la prosecuzione del racconto che per un ricordo genuino.
“Una sera ero a cena a casa sua: dunque, immaginate il personaggio, quarantacinquenne figlio della borghesia rampante, commercialista di successo, uno che guadagna molto bene e che non fa nulla per nasconderlo. Ce l’avete?”
Annuirono tutti eccetto Fulvio e la mostruosa fidanzata, le cui labbra rimasero fortunatamente sigillate.
“Durante la cena, interpellai il figlio unico – diciotto anni antipatico come pochi, più saccente del padre, se capite il tipo – il quale in quinta liceo riservava giudizi sprezzanti su tutto e il contrario di tutto, che sotto lo sguardo estasiato dei genitori continua a gettare palate di merda su ogni singolo insegnante, ogni personaggio pubblico, ogni politico e ogni musicista. Per interrompere il carosello gli domandai cosa avrebbe fatto dopo la maturità e lui, col medesimo tono, raccontò i suoi programmi, che avrebbe fatto economia e commercio, si sarebbe laureato in corso con voti brillanti, e che presto avrebbe affiancato il padre nel suo studio, guadagnando una barca di soldi, eccetera eccetera. A un tratto ebbi una intuizione e gli domandai a bruciapelo se fosse contento così, cioè se economia e commercio fosse esattamente quello che desiderava, e… giuro, in un istante quel piccolo demone scomparve, e al suo posto vidi un bambino insicuro e timido, che disorientato mi rispose che, no, lui avrebbe voluto fare geologia. Subito tuttavia, incalzato dagli sguardi preoccupati dei genitori, riprese la prosopopea di prima, e disse che i geologi sono tutti degli sfigati, morti di fame e che erano solo fantasie, che la sua vita è già tutta scritta.”
In quel momento nella sala ping-pong si fece un silenzio carico di contenuti: avevano capito. Troppo perché Stefania accettasse di buon grado un altro sconfinamento.
“Ah bene! Così oltre ad accanirti contro gli sposi hai preso di mira anche il rapporto tra genitori e figli? Ne devi avere viste di cose brutte nella tua infanzia.”, teneva ancora le braccia conserte in segno di sfida. Lui la scrutò per qualche istante, con una particolare mescolanza di orrore e ammirazione. Si sentiva come un imbianchino che viene ingaggiato per tinteggiare un monolocale e, con teloni, scaletta, secchi e pennelli, apre l’ingresso di un super attico. Aveva un debole per le sfide difficili. Nuovamente don Patrizio, come il moderatore di una tribuna politica, fu lì per intervenire per limare i toni personalistici della ragazza, ma Piero gli fece cenno con la mano di lasciar correre: si sarebbe difeso da solo. E poi non voleva che il prete si esponesse troppo.
“Ne ho viste di brutte e di bruttissime, hai ragione. E, per dirla tutta, sì, un po’ c’è l’ho anche con i genitori, specialmente se fanno crescere i figli in un bozzolo di aspettative che finisce per rattrappirli. Cosa che accade molto più frequentemente di quanto pensi.”
“E cosa hai fatto?”, Giulia era decisamente più interessata al piatto principale che al contorno, “Intendo, insomma, con i Tardioli…”
“Oh una cosa semplicissima, sebbene non immediata. Ovvero, cambiai frequentazioni.”
Fece una pausa.
“Diventare adulti è mestiere più in salita di quanto non si immagini, e la parete più difficile da superare è quella della coercizione dell’ambiente nel quale si vive, dove se tutti dicono che esiste un unico modo per fare una determinata cosa, può non bastare una vita per riconoscere, accettare che la si sarebbe voluta fare diversamente.”
Un silenzio di gomma avviluppava gli oggetti sul tavolo.
“Che male c’è nell’insegnare a un bambino che una cosa la si debba fare così piuttosto che in un altro modo?”, berciò Stefania in affannoso recupero. Stava perdendo punti e la mossa era un azzardo, tuttavia non poteva astenersi: “Cosa dovrebbe dare ai propri figli un padre se non ciò che ritiene meglio per sé?”
“Può non esserci nulla di male, oppure tutto, a seconda di quale sia il livello di costrizione della gabbia che si prepara…”
“Una gabbia addirittura?”, Giulia non si capacitava del passo falso di Piero, “Cioè quando insegnerò a mio figlio ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, gli mancherò di rispetto? Lo getterò in una prigione?”
“Qualcosa del genere…”
“Questo mi sembra davvero esagerato!”, disse Riccardo rivolgendo lo sguardo altrove. Stefania pregustava l’imminenza del successo.
“Puoi spiegarti meglio?”, incalzò Giulia.
“Mah non so. Intanto ci sono alcune cose evidenti, che come tutte le cose in piena luce non le vede nessuno.”, fece una pausa lunghissima, “In primo luogo non è detto che imporre a tuo figlio di attraversare sulle strisce otterrà il risultato…”
“Ma certo!”, schiumò Stefania stropicciandosi le mani furenti, “Adesso incolpi gli educatori anche la responsabilità delle distrazioni?”
Piero si fermò. Qualcosa lo disturbava, ma di un ordine diverso rispetto allo sdegno contro cui era andato a sbattere. Affatto. Quello era una componente essenziale del “pacchetto divertimento” con cui si era prestato alla serata. No, qui riguardava uno sgancio ulteriore, un po’ più in basso, più remoto rispetto al livello della discussione. Era consapevole che procedere di paradosso in paradosso non aiutasse quelle giovani anime a seguirlo in tutti i suoi meandri, e un’acerrima nemica come Stefania ci poteva anche stare. Il problema era come quei giovani, si irrigidissero, e resistevano ad abbandonare i propri reticoli di pensiero, gretti astiosi ma rassicuranti; bastava poco, davvero poco, per soffiare appena sulla cenere di consuetudini incistate, convinzioni arrugginite, per raggiungerlo lì dov’era. Non pretendeva invero di essere depositario di chissà quali verità, ma desiderava che quei ragazzi comprendessero
“Certo che sì. Insegnare a un figlio che deve attraversare sulle strisce si rivela spesso meno utile a salvargli la vita, di quanto a scagionare preventivamente il genitore se qualcosa andasse storto.”
“Don Patrizio, ma ti rendi conto?”, Stefania radiosa come un angelo della vendetta, affondò il colpo, indicando Piero con le quattro dita della mano destra mentre teneva il pollice piegato al centro, “Mi dispiace per te, perché hai detto che è un tuo amico. Ma per quante ore dobbiamo lasciarci prendere in giro? Credevo di essere a un corso per fidanzati mentre mi ritrovo all’one man show di un pazzo furioso.”
La giovane sapeva d’aver raggiunto il climax, e ora doveva lasciar partire il colpo di grazia, una bordata tale cui l’avversario non si sarebbe rialzato, e avrebbe messo in grave imbarazzo il padrone di casa – ma ci sarebbe voluto ben altro perché perdonasse a don Patrizio quella goffa neutralità – e infine riscosso una leadership indiscutibile presso le altre coppie, rispetto chiunque calpestasse quel territorio, a cui aveva lavorato con dedizione scrupolosa da quando aveva ricordi collegati alla parrocchia. E se fino a poco prima era stata indecisa se puntare a un risultato inferiore mostrandosi indignata, sì, ma andandosene dal quel consesso finendo la partita con una sostanziale parità, ora la sua intelligenza animale le diceva che doveva puntare alla giugulare. Anche quel, quel… rincoglionito di Marco, per ritrovare la confidenza avrebbe dovuto pagare un pedaggio molto elevato. Aveva già escogitato una pletora di “musi”, silenzi, frasi smozzicate e moine, che l’avrebbero fatto fluttuare colpevole e insolvente a lungo, prima di rientrare nel rango.
Don Patrizio effettivamente, in imbarazzo, ci si sentiva; ma non per le affermazioni di Piero, la cui propensione allo scandalo gli era nota da sempre, quanto per lo sforzo di Stefania nel divaricare la posizione sua e quella dell’ospite. Aveva chiaro, suo malgrado, che sarebbe dovuto intervenire anche se non sapeva come salvaguardare contemporaneamente se stesso – o meglio, la Madre di cui faceva indegnamente le veci -, e tutti gli attori sul palco. Ma prima che traducesse i propositi in realtà, intervenne nuovamente Piero, per nulla rattrappito. L’uomo in clergyman guardò l’amico con gli occhi sbarrati, e mai fu in grado di dire se si trattasse di gratitudine o ammirazione.
“Se non fosse così, perché occorrerebbe tanta foga per difendersi?”
Gli occhi di Stefania sbucarono dalle palpebre come tuorli dai gusci; con quella mossa la squadra avversaria s’era riportata in vantaggio, perciò finse il medesimo interesse degli altri. Anche perché non poteva sottovalutare il fascino che quello, quello… stronzo, sì, proprio stronzo, esercitava su Marco, una attrazione malata, retaggio di qualcosa cui aveva lavorato anni per estirpare. E quegli imbecilli che lo guardavano nemmeno fosse stato Gesù Cristo sulla croce? Non si vergognavano di restare a bocca aperta davanti a uno spandiletame? Non era Gesù, un retore, un demone era, che fomentava la distorsione dove occorreva armonia. Ma doveva essere accorta, molto accorta, perché quel bastardo era un avversario molto pericoloso. Tacque, per il momento.
“Non occorre molto per farsi del male.”, Piero proseguì con la sua cantilena “I figli di genitori iperprotettivi scrivono biografie piene di corse affannose al Pronto Soccorso, ginocchia lussate, scapole strappate, e fratture composite, ottenute nei modi meno immaginabili. Possibile che non vi sia una relazione? Se un genitore volesse davvero far correre meno rischi a suo figlio può seguire due strade; o avviluppando definitivamente l’esistenza di suo figlio in un bozzolo protettivo, impedendogli non solo di salire su una moto di alta cilindrata, ma anche biciclette e monopattini, e imponendogli una lunga serie di contromisure anche per attraversare la strada…”
“E funziona?”, domandò un attentissimo Riccardo.
“Chi può dirlo… se funziona, sì! E se non funziona queste misure alleggeriscono, come dicevo, il cuore dei genitori dall’accusa di non averci provato. Il senso di colpa è un istinto subdolo, pronto e agguerrito se si sente minacciato.”
Fece una pausa.
“Funziona così: ci si convince che il mondo è un posto pericoloso, che non si fa mai abbastanza per tenere al sicuro le persone cui si vuole bene, confortandosi nelle loro precedenti convinzioni e preparandoli, casomai ne avessero l’occasione a rifare tutto daccapo…”
“Oppure…?”, la voce di Giulia risuonò di una curiosità viscosa.
“Oppure non saprei. Si tratterebbe di giocarsi la partita su un terreno differente, mettendo nel conto la possibilità del rischio, o delle dinamiche autodistruttive, per il semplice fatto che esistono.”
Le parole erano quelle attese. Avevano capito.
Con una punta di dispiacere Piero si rese conto d’avere perso il filo. O di doverlo ritrovare.
“Come siamo arrivati qui?”
“Stavamo dicendo del condizionamento che l’ambiente e l’educazione possono esercitare su una persona.”
L’uso, quasi confidenziale, che Riccardo fece della prima persona plurale, irretì la biondissima Stefania più che una attestazione pubblica di consenso. Ma le toccava aspettare ancora. Prese tuttavia a tormentarsi il labbro inferiore tra le gengive, come nei momenti d’ansia divorante. Doveva placarsi, e doveva farlo in un tempo utile.
“Giusto, grazie Riccardo. Però io preferisco parlare di aspettativa, piuttosto che di condizionamento.”
“Che differenza c’è?”, la domanda era partita da don Patrizio, le cui guance si imporporarono come se avesse fatto qualcosa di disdicevole. Piero gli sorrise invece, misurando una spontaneità rara in chi lo conosceva da una vita.
“Magari niente. Ma ‘aspettativa’ è una parola più intima, e descrive non tanto un fenomeno sociale, quanto il tipo di pressione che può essere avvertita soggettivamente.”
“Capisco, capisco. Potresti spiegare ai ragazzi quali sono i problemi che derivano dal sottoporsi a un’aspettativa?”, ribadì il presbitero afono e neutrale, mimetizzando così la cuspide di curiosità che lo aveva appena punto.
“Intanto vorrei sottolineare una cosa: che il tipo di pressione che sto descrivendo non è semplicemente da condannare. Non è ‘il Male’.”, Piero si fece vago, perlustrando il tavolo alla insensata ricerca di un cognac, o un whisky biondo, dovendo ripiegare disgustato sulla gazzosa tiepida, “Forse avevate ragione tutti voi, perché in senso assoluto, se non vi fossero aspettative probabilmente vivremmo in un giardino dove ogni pianta cresce sghimbescia, e questo potrebbe rivelarsi come un problema.”
“Perché?”, Riccardo era confuso per l’ennesimo zig-zag.
“Perché la società ‘serve’, perché le convenzioni sociali aiutano a evitare i comportamenti eccessivi e quelli carenti, perché accettare che le cose debbano andare in un determinato modo aiuta a evitare l’improvvisazione, o trovarsi di fronte scalate vertiginose che non tutti sono attrezzati per affrontare.”
“Io non riesco a capire, ci fai una testa così per dire che dovremmo liberarci dalle pressioni sociali, e stavi pure per convincermi, e poi fai marcia indietro in questo modo?”, il volto di Giulia era passato da una fierezza altera a una remissione confusa.
“Non credo di avere detto che dovremmo liberarci dalle aspettative, ma solamente che possiamo – o dovremmo potere -farlo. C’è una bella differenza…”
“Ah sì?”, anche Riccardo si sentiva tradito, “Io però non la vedo tutta questa differenza. A meno che tu intenda dire che la libertà sia una cosa per pochi eletti, e non per tutti.”
“Io non dico che la vera libertà sia per pochi eletti, ma certo non è per tutti.”
Di nuovo Piero valutò quanto poco appagante si fosse rivelato il bicchiere di plastica che girava tra le dita. Gli occorreva una pausa per raccogliere le idee. Gli bastavano pochi secondi per pettinare i pensieri. Il suo cinismo si rivelava infine per una clessidra che funzionava alla rovescia, che si svuotava mano mano che si riempiva la pancia di sabbia. Forse non era più il vecchio bastardo cinico che a questo punto avrebbe goduto nel portare gli altri commensali sul fragile ghiaccio del dubbio, sotto l’ombra gelida degli iceberg del paradosso e della contraddizione. I ragazzi, persino Stefania, gli facevano tenerezza in un modo per lui inusuale. Non poteva lasciarli lì mentre le loro certezze, a causa sua, scricchiolavano. Però gli occorrevano alcuni dannati secondi, e poi si sarebbe spiegato. Ma come fare? Occhi disillusi lo interpellavano, e avrebbero interpretato ogni ritardo come una resa e un tradimento. Gli venne in soccorso un’ambulanza che passava a sirene spiegate sulla tangenziale, a ridosso dell’oratorio. Il suo lugubre latrato rovesciò ettolitri di angoscia sulle persone nella stanza, ma Piero poté ritrovare il bandolo altrimenti perduto.
“La libertà è come l’alpinismo. A tutti piace vedere le diapositive con vette incontaminate e il cielo soprannaturale delle altitudini, ma poi ad arrampicarsi effettivamente con corde e ramponi, è un’esigua minoranza.”
“Vuoi forse paragonare la libertà alla tecnica di un rocciatore esperto?”, Marco scuoteva la testa per il disappunto.
“Voglio dire che per salire sulle pareti ghiacciate del Cerro Torre occorre coraggio; coraggio e polmoni. Altroché tecnica.”, proruppe Piero.
“E cosa occorre per sposarsi?”
Questa volta fu Piero a riservare a Marco uno sguardo pieno di commiserazione. Come poteva non capire? Davvero nel cuore dei ragazzi si annidava un cono d’ombra che impediva loro di cogliere l’unica cosa indispensabile?
“Ma come?”, disse trafelato quasi avesse dovuto compiere una rincorsa, “La cosa necessaria, l’unica cosa davvero necessaria è amare qualcuno, amarlo realmente, amarlo fino in fondo.”
Marco lo guardava ora perplesso. Non gli consentì tuttavia di formulare una domanda.
“Volere l’Altro fino a perderlo, e non reclamandolo come un ordine inevaso.”
Silenzio attonito.
“La cosa più straordinaria di ogni relazione è che dura fino a un istante prima che uno dei due decida che sia finita. Se riuscite a volere questo, se riuscite ad amare qualcuno senza ‘pretenderlo’, senza esigere il rispetto di un contratto, per quanto necessario, per quanto supponiate essere quel legame ‘voluto da Dio’, perché nessun Dio che vi meriti può volere che qualcuno permanga in un luogo dal quale desidera uscire.”
Le parole piombarono nella stanza come una giostra del Luna Park che si sgancia dal supporto travolgendo la folla ignara. Lo sgomento imponeva tuttavia l’emersione di un fattore che ognuno aveva avvertito come necessario, ma che nessuno era riuscito a codificare. Sino a quel momento.
Fu ancora l’ospite a prendere la parola.
“Uno dei Padri della Chiesa, Sant’Agostino, ha scritto che ‘l’Amore è Dio’. Capite? Non Dio è Amore, dove poteva arrivarci qualsiasi chierichetto, o berciare qualunque antifonista al Rosario, ma l’Amore è Dio. Ecco io credo che questa sia l’unica cosa capace di rendere il matrimonio ‘sacro’ Non tutta la manfrina della indissolubilità…”
“Se l’Amore è Dio, forse è anche eterno, e l’indissolubilità coniugale potrebbe essere una conseguenza di questa verità…”, don Patrizio dopo il lungo silenzio aveva scelto una tempistica congeniale per sigillare la discussione in un modo confacente al ruolo che pur sempre rivestiva, “Non credi Piero?”
L’amico lo guardò con un’irruenza da metterlo in imbarazzo.
“Stai scherzando vero? Certo che in ogni amore, se autentico, c’è qualcosa che resiste al tempo. Ma non nel modo ricattatorio intenso dai tuoi superiori. È una eternità mai esigibile, la cui principale caratteristica è lasciare le persone libere di fare ciò che vogliono; per quanto possa essere doloroso, o per quante convinzioni possa infrangere. Una pianta perenne verde che avvizzisce nell’istante stesso in cui qualcuno pensa di avere diritto alla frescura della sua ombra. Una eternità gracile come la brina, pronta a dissolversi al primo raggio del possesso. Un infinito che finisce non perché uno dei contraenti rompe il patto, ma perché l’altro esige venga rispettato.”
Le parole esplosero come lava incandescente sul volto dei fidanzati. Anche don Patrizio era in preda alla confusione. Perché le parole di Piero chiarificavano la serata, ma allo stesso tempo aprivano dighe di pensieri sconosciuti. Pure Stefania vacillò per qualche istante, mentre Marco abbassava gli occhi cercando un punto di fuga nelle linee del ping-pong. Riccardo era paonazzo come se avesse fatto a pugni, mentre Giulia era cupa, infuriata col fidanzato latitante, che avrebbe dovuto esserci.
Ma fu ancora Piero a rincarare, se possibile, la dose:
“Ecco perché il matrimonio è la tomba dell’amore, perché c’è libertà solo nel divenire, e se si firma un contratto le cui condizioni non potranno mai più essere cambiate, allora diventerà una realtà molto solida, ma come le pareti di noce di una bara, o come i marmi di un colombario. Ma non avete mai fatto caso che i matrimoni siano tutti cupi? E come potrebbe essere diversamente se la parola dominante, quella più decisiva è, ‘fino a che morte non vi separi’. Un rito di morte. Forse è nella natura del matrimonio – religioso o laico – cercare una giurisprudenza solida, che valga per tutta la vita. Ma non è così per l’amore. La sua natura è di essere il contenuto del dono, e non l’involucro.”
“Bravo, bravo!”, lo tsunami di pensieri che si abbatté sull’uscio dei cuori, fu interrotto dalle parole iniettate d’odio di Stefania, che aveva preso anche ad applaudire sarcasticamente, “Non c’è che dire: un’interpretazione magistrale, sei un vero animale da palcoscenico, un grande attore.”
Clap insolenti le crepitavano dalle mani, estorcendo i flussi di pensiero, introducendo una distonia che rapì gli sguardi. Quando fu certa di avere l’attenzione necessaria, Stefania si giocò le ultime carte che aveva in mano. Sebbene neppure lei fosse completamente consapevole da dove provenisse tutta l’ostinazione, era certa di doversi aggiudicare la mano più importante. E il piatto era troppo ricco per lasciarlo a un antagonista così odioso.
“Sei venuto qui a darci lezione su tutto, su cosa sia l’amore, il matrimonio, su come dovremmo comportarci nelle nostre esistenze, e persino a spiegarci chi è Dio e come si dovrebbe credere in Lui. Complimenti…”
L’unico a restare tranquillo fu Piero. Nello sguardo non vi era animosità, né rancore, come se l’esacerbazione degli animi non lo riguardasse. Non più. Uno sguardo che fece stillare più odio nella Valchiria che se avesse risposto a tono.
“Sei contento di quello che sei venuto a fare questa sera? Portare scompiglio in persone che non ne sentivano alcun bisogno…”, sventagliò le braccia verso gli astanti, che sentiva sfuggire di minuto in minuto, “Non credi che ognuno di noi fosse qui con un barlume di consapevolezza di ciò che stava facendo? E che se forse abbiamo scelto di prometterci a qualcuno nella sacralità del vincolo cristiano, lo facciamo a ragion veduta? Non ritieni possibile si possa sentirsi pronti ad affrontare il passo confidando in un Dio che porta a compimento promesse impossibili per gli uomini? E comunque grazie, grazie davvero, del processo alle nostre intenzioni.”
Quando chiuse la frase Stefania sapeva di meritarsi un plauso, cui tuttavia non avrebbe goduto. Aveva compiuto un lavoro straordinariamente difficile per rimettere le cose a posto, si era esposta molto di più di quanto avrebbe voluto, ma temeva che il seme del dubbio avesse già germinato nel cuore di quegli sciocchi. Finalmente la mano di Marco era tornata sotto il suo controllo, dopo averlo eluso per quasi l’intera serata. Ne percepiva lo stato confusionale dai polpastrelli. Erano tutti confusi, il silenzio raggiunse un inquietante picco. Ma non finiva qui! Ah no, questa volta la pazienza che aveva avuto con don Patrizio avrebbe dovuto portare conseguenze, e se fosse stato necessario avrebbe scritto al Vicario, o direttamente all’Arcivescovo, per segnalare una scelta così disdicevole, lo avrebbe fatto eccome.
“No.”, la voce di Piero arrivò come il lampo di flash attivato da un fotografo inetto durante lo sviluppo di un prezioso rullino nella camera oscura.
“No… cosa?”
“Mi hai fatto un bel po’ di domande, alcune retoriche, altre promettenti, ma rispondo solo all’ultima, e cioè no!”
“Spiegati meglio.”
“Mi hai chiesto se ritenessi che fosse possibile affrontare questo passo confidando in Dio, e io ti rispondo di no.”
“Perfetto! Ci mancava solo che ti mettessi a giudicare la fede di perfetti estranei…”, Stefania stava recuperando molto del terreno perduto, perché gli sguardi intorno presero a lampeggiare malevoli nei confronti di Piero.
Tuttavia lui rispose ancora serafico:
“Non ho detto affatto che non è possibile che tu abbia fede, anche perché la domanda non era quella. Ho detto solo che sono certo non si possa usare la leva della fede per rendere sufficientemente autentica, percorribile o banalmente sopportabile la strada che si apre con due che si sposano davanti a un prete.”
“O bella, e perché?”, Stefania raccolse di nuovo le braccia intorno al petto, ripristinando la posa battagliera e dannatamente femminile di poco prima.
“Per la stessa ragione che ho usato un paio di ore fa con il tuo fidanzato. Perché non esiste una ‘legge’ che faccia funzionare i matrimoni. Nemmeno la legge di Dio, perché se diventasse una meccanica perderebbe l’unica cosa che ancora riesco a rispettare nella teologia cattolica, ovvero che vi possa essere una Grazia. La Grazia funziona come i miracoli, avviene se avviene, ma non perché ‘debba’ avvenire, altrimenti il vostro sacramento sarebbe come il frullatore che basta pigiare l’interruttore e comincia a trasformare la frutta in poltiglia. Non esiste quell’interruttore. Oh no, no, grazie..! Che Dio vi scampi dal matrimonio-minipimer, che basta una carica ogni tanto…”
“Basta! Non intendo restare qui a farmi insultare a oltranza, ad ascoltare i deliri di una persona gravemente disturbata. Scusa don Patrizio, ma questa volta hai fatto una cazzata.” Stefania si era alzata di scatto, con un movimento sincopato. Il sacerdote non sapeva se rispondere, ma si limitò a un’espressione elusiva e una levata di spalle, rassegnata che voleva dire, (“Cosa ci posso fare Stefania? Mi dispiace, ma mentirei se dicessi che non volevo che accadesse.”)
“Dai Marco, andiamo…”, disse lei stridula, col turpe presentimento d’avvicinarsi alla linea dove si perde molto di più di quanto si voleva, da principio, mettere in gioco. Teneva il braccio rigido verso il fidanzato. Marco sembrava un grizzly risvegliato dal tepore del letargo, assai poco propenso a correre fuori dalla caverna.
“Scusa, ma non capisco la tua rabbia. Io vorrei ancora ascoltare…”
Lei commise l’errore di impuntarsi, laddove avrebbe avuto tutto l’interesse a dimostrarsi più paziente. L’orgoglio la accecava, facendole preferire la strada di uno sfracello, molto meno opportuna rispetto a un formale armistizio dove vecchie strategie avrebbero potuto sopravvivere solo nascondendosi alla vista. Perciò non gli rispose neppure, e rimase con la mano ancora tesa e pretenziosa. Marco irretito si girò verso il tavolo. Allora Stefania si alzò, di scatto e si avviò verso l’uscita. Non avrebbe pianto. Non voleva piangere. Tradì tuttavia il rovescio che l’agitava interiormente andando a raccogliere le prime lacrime che s’affacciavano con l’interno del polso. La vulnerabilità, così palese in chi aveva fatto di tutto per occultarla, turbò Piero, che da parecchio aveva smesso di nutrire ostilità per la ragazza; fu quasi tentato di seguirla per darle conforto, ma ovviamente era l’ultima persona a poterlo fare. Né poteva essere Marco. Come avesse impartito un comando silenzioso, fu dunque don Patrizio a oltrepassare la grande porta a vetro, dove il buio aveva deglutito l’amazzone sconfitta. L’amico gli fu grato d’aver usato la cautela.
“Puoi spiegarti?”, Giulia aveva infine raggiunto la boa cui si era abbarbicato Riccardo.
“A me sembra che la chiesa, erede di un pessimismo biblico sulla natura dell’uomo, applichi un principio rovesciato, ovvero che per uomini fragili occorre costruire celle robuste, mentre dovrebbe partire dal presupposto che solo uomini liberi e consapevoli, e grandi amori, possono costituire legami duraturi. La chiesa educa gli uomini a essere prudenti, non felici.”
“Anche la prudenza ha senso…”, borbottò Giulia più per se stessa che per gli altri.
“Ce l’ha eccome. Ma un po’ meno per chi annuncia – o almeno tale si ritiene – il più grande messaggio di speranza mai comunicato all’uomo.”
Intanto don Patrizio era rientrato, con l’aria costernata di chi ha insistito un gesto la cui inutilità era stata sentenziata molto prima.
Una moto che passava distante ululò fuori giri per qualche secondo deformando il ruvido silenzio che avvolgeva ogni parola dentro la stanza. Di nuovo Piero, con un accento di dolorosa rassegnazione:
“Un avvocato della Sacra Rota, tempo fa, mi disse che se avessero dovuto annullare i matrimoni contratti ‘senza amore’, ne sarebbero rimasti in piedi solo il 10%. Ecco, se nella chiesa questo fosse un immaginario largamente diffuso, come temo, allora significherebbe che il veleno sia entrato in profondità, e che sia troppo tardi per qualsiasi antidoto; se la frase di Agostino fosse vera, come potrebbe funzionare il Sacramento ‘senza Dio’?”
“Beh, tu stesso hai citato la Sacra Rota, il che comporta, tralasciando il pessimismo dell’avvocato, che sia la chiesa stessa a creare al suo interno uno spazio di riflessione per stabilire, a condizione di non abusarne, quali matrimoni siano stati celebrati senza che i ministri – lo sposo e la sposa – lo desiderassero autenticamente. E ti garantisco che la Rota prende estremamente sul serio i casi sottoposti.”
Benedetto don Patrizio, Piero lo guardò con disarmante tenerezza, poiché vedeva l’uomo prima del prete, e il prete dentro quell’uomo; talmente buono che voleva portare ogni costo un risultato che non traumatizzasse nessuno: ecco, in quella disposizione d’animo vedeva l’agape di cui aveva immaginato nei pochi anni di militanza ecclesiale della sua adolescenza, e che se avesse incontrato persone così, che ne erano provviste tanto per un retaggio soprannaturale quanto per una docilissima disposizione d’animo, avrebbe forse resistito un po’ di più. Don Patrizio, uomo di fede e non d’apparato, si comportava come quei bambini che quando vedono i grandi litigare piuttosto che fuggire su un pianeta distante si lanciano a difendere il più debole. E in quel momento era la chiesa messa a mal partito. Voleva bene all’uomo che nascondeva la propria incompiutezza sotto un abito talare; l’adulto che conservava molti tratti del bambino ch’era stato. Gli volle ancora più bene in quel frangente ammezzato dai rumori attutiti della tangenziale e da silenzi crespi, vedendolo animato da preoccupazioni e affetti purissimi. Un ‘uomo materasso’, ecco cos’era don Patrizio, nato perché chiunque lo avvicinava non si facesse troppo male. Un autentico seguace del Risorto.
Per questo gli dispiacque doverlo contraddire:
“E chi può stabilire quando l’uso di quello spazio non si configuri come un abuso? Tu? Io? L’avvocato?”
Gli doleva d’infierire, ma non poteva evitarlo. Fece rotolare i pensieri lungo il braccio, da lì alla mano sino al bicchiere. Poi li strinse nuovamente tra le meningi:
“Hai ragione su una cosa… la Sacra Rota è serissima nel valutare le situazioni, ma così esaspera il paradosso: perché usare tanta attenzione nel valutare quando un matrimonio finisce e sostanzialmente nessuna quando questo inizia? Come se si chiedesse a un ingegnere di esibire le proprie credenziali solo quando un palazzo crolla invece di presentarle appena prima di rendere operativo il cantiere? Non è grottesco? A ben vedere, per come è stato concepito, il matrimonio sacramentale non è soltanto una fabbrica di infelicità, ma anche una efficientissima catena di montaggio di ateismo.”
Non c’era più nulla da dire. Altre cose sarebbero state di troppo, avrebbero ingolfato un motore appena dopo averlo acceso. Dopo avere scolpito una immagine così limpida, non occorreva più fare ricorso alle parole. Il nitore delle molte cose rotolate sul tavolo da ping-pong, era tanto, troppo forse, insopportabile, necessario; adesso occorreva tempo per elaborare, tirare fili invisibili e tagliarne altri, ritenuti indispensabili fino al giorno prima. Come ceri consumati davanti a un altare votivo, che si sciolgono nel buio per tornare a solidificarsi, col tempo, in fantasie della materia imperscrutabili. Toccava ai ragazzi farne qualcosa. Qualunque cosa.
Dovevano chiudere, perché il silenzio delle giornate successive – e il frastuono delle notti – avrebbe lavorato in profondità. Non ora, non subito.
“Credo che per questa sera possa bastare così.”, disse il presbitero guardandosi il polso, fingendo l’orologio avesse già scritto una sentenza inappellabile. Si alzò, così fosse chiaro non avrebbero avuto modo di indugiare oltre.
“Quando ci vediamo la prossima volta, Riccardo?”
“Io? Credo… mercoledì, tra due mercoledì.”, rispose quello in uno stato confusionale. Parlava con la lingua impastata dei molteplici risvegli. Don Patrizio congedò i fidanzati in fretta, il cronografo aveva preso adesso effettivamente a bruciargli sotto il polsino. Dimenticò persino la prassi della preghiera conclusiva, e Riccardo si guardò bene dal correggerlo.
Alcuni se ne andarono senza nemmeno lo scrupolo di salutare l’ospite o il padrone di casa. Giulia si avvicinò porgendo la destra a Piero. Mostrava sia gratitudine quanto fastidio per i troppi angoli che avrebbe dovuto rovistare. Riccardo, ancora provato salutò con aria sparuta.
Nel volgere di un paio di minuti si erano allontanati tutti, eccetto lo sballone, che nemmeno s’era alzato. Si massaggiava piuttosto la mano sinistra, quasi ne avesse recuperato l’uso da poco.
Don Patrizio, interdetto per il protrarsi, provò a divincolarsi con qualche occupazione, come raccogliere i piatti di plastica, gettare i bicchieri umidi nel sacco nero, fino quando non prevalse una forma remota di senso della responsabilità nei confronti del giovane. Del resto era stato proprio il prete a seguire Stefania fino alla macchina. Non che fosse riuscito a dire qualcosa di particolarmente importante, o che avesse potuto accogliere qualche confidenza, ma questo Marco non lo poteva sapere. Non lo conosceva bene, però era un giovane sensato, in gamba, con risorse tali da comprendere, provarci almeno! Perciò appoggiò contro un muro la ramazza con cui aveva iniziato una sommaria pulizia, e fece per avvicinarsi a Marco. Tuttavia si ritrovò spiazzato quando questo, senza neppure premiare la sua iniziativa, alzò gli occhi verso Piero e gli domandò:
“Cosa devo fare?”
Maledizione! Don Patrizio si ricordò che quando s’era fatta strada l’idea di invitare Piero, aveva anche pensato che tra lui e Marco si sarebbe creata una alchimia profonda dovuta alle molte affinità, alcune elettive. Ma ora che celebrava l’esattezza della propria intuizione non poté fare a meno di esserne, almeno un po’, angustiato. Era stato scavalcato. Non solo lui, ma tutta la chiesa. E un fastidio ancora più grande lo percepì quando registrò la innaturale spontaneità con cui Piero gli rispose. Come se per tutta la serata quei due avessero continuato in un colloquio separato, usando il linguaggio invisibile delle persone eccentriche, marginali, speciali…
“Questo nessuno te lo può suggerire, non io, né don Patrizio e nemmeno il Padre Eterno.”
“Certo, ma non…”
“Cosa? Non ti eri accorto mai che fosse un sergente di ferro? Occorreva questa sera perché te ne accorgessi?”
Marco sorrise.
“No davvero! È che in fondo ogni tanto un sergente fa pure comodo.”
“Mi pare ovvio. Ma se tu la sposerai non sarà ogni tanto. In fondo questo è straordinariamente onesto, che l’altro sia ‘là fuori’, eternamente irriducibile al metro con cui noi misuriamo il vantaggio o lo svantaggio della sua presenza. L’altro è distante, che sia a un centimetro o un milione di chilometri.”; per un pallido istante i suoi occhi lo portarono in un altrove inaccessibile, e la sua espressione si trasmutò in un dolore impervio, silenzioso, solenne; ma si riebbe immediatamente: “E’ solo quando registri questa distanza che puoi scegliere di averlo accanto a te. ”
“Per sempre?”
“Finché non cambi idea, sì.”
Questa volta fu a Piero a sfoderare un sorriso contagioso. Anche per Marco era giunto il momento di congedarsi. Era stato il testimone di una epifania che, come tutte le estasi, non sarebbe durata, ma fintanto che ne avvertiva il riverbero, l’avrebbe usata per guadagnare tempo e distanze. E distante era già arrivato, sebbene non sapesse ancora dov’era. Avrebbe voluto abbracciare tanto Piero quanto don Patrizio, ma temette la goffaggine, perciò andò a stringere il gomito del primo, accettando docile un braccio sulle spalle dal secondo.
Quando si accomiatò, anche per. Piero era scoccata l’ora del ritorno.
“Mi accompagni all’auto?”
“Dammi un momento che chiudo tutto. Poi vado anche io.”
Senza replicare l’altro uscì con il pacchetto di sigarette già in mano.
Il prete si risolse a rimandare tutte le operazioni al giorno dopo, quando una delle petulanti vedove della San Vincenzo lo avrebbe rimproverato per il macello e poi avrebbe fatto il lavoro cento volte meglio di come poteva lui. Un piccolo peccato di accidia – di certo non quello in cui inciampava più volte -, una volta tanto poteva trovare una cittadinanza provvisoria, avallato dall’importante risultato conseguito quella sera. Percorse l’intero quadrilatero, tanto per verificare che nessuno avesse dimenticato un oggetto indispensabile, di quelli che richiedessero una telefonata notturna, per intendersi. Poi passò alla elaborata procedura dello spegnimento delle luci, cui si sottopose con una sequenza abitudinaria che gli impediva di rimanere con l’ultimo interruttore al buio. Infine, indossato il giubbotto blu scuro, recuperò il pesante mazzo di chiavi che Alberto gli aveva portato tre ore – o forse quattro? – prima. Poi uscì lasciando che la serratura del portone gli scricchiolasse alle spalle.
“Stavo per andare…”, la voce di Piero lo sorprese mentre il bengala di un mozzicone incandescente gli segnalava la posizione.
“Ma che poca pazienza che hai.”
“Mica faccio il prete, io!”
“Allora cosa te ne pare?”, domandò il presbitero avvolgendo la gola con una sciarpa superflua. Poi mentre si aggrappava al braccio dell’amico si accorse di quanto incongrua fosse la domanda, quindi si corresse prima che l’altro glielo facesse notare.
“Sai, sono davvero contento di questa sera.”
“Ne sei sicuro?”, disse Piero scettico.
“Oh sì. Sei venuto qui per farli pensare, e non dubito che qualcosa hai smosso.”
“Solamente? Tutto qui?”
Il prete esitò per un istante, non gli piaceva tirare conclusioni, e ancor meno farlo per portare all’ingrasso un ego ingombrante quanto quello quello di Piero. Aveva portato al pettine molti nodi attorcigliati, perciò qualcosa glielo doveva consentire.
“No, hai ragione. Sei stato formidabile.”
Nella penombra lunare vide comparire un sorriso compiaciuto.
“Cosa credi succederà?”
“Non è un problema mio.”, rispose il prete mentre con i polpastrelli impartiva una nuova sconfitta ai follicoli della fronte, in alto, ”Ciò che occorreva a questo gruppo era vedere le proprie scelte in una prospettiva differente, e l’obiettivo l’ho…, lo abbiamo portato a casa. Cosa sceglieranno è affar loro.”
“Secondo me Stefania domani telefona in curia, e ti toccherà una lavata di capo.”
La voce di Piero espresse in questo passaggio una nota di autentico dispiacere. Don Patrizio gli fu grato che cogliesse il dilemma interiore, uno di quelli che i preti della sua fatta tengono per se stessi.
“Può darsi, ma quello che devo domandarmi, è se ne valesse la pena, e francamente credo di sì.”
Piero si fermò e lo scrutò nella penombra con un bagliore di ammirazione. Ecco il buon pastore in cui, se vi si fosse imbattuto con tempistiche differenti, non avrebbe lasciato da così tanto tempo le corti degli oratori. Ma si trattava di una storia che non sarebbe mai stata scritta.
Intanto arrivarono alla catena dov’era parcheggiata la Toyota. Sembrava appollaiata lì da un tempo scollegato dal presente.
Esitando come un bimbo impacciato, don Patrizio a un certo punto domandò:
“Hai più sentito niente di…?”
Piero mentre rovistava le tasche alla ricerca delle chiavi finse di non capire.
“Di chi?”
“E dai! Hai avuto sue notizie?”, Don Patrizio rinnovò il tentativo detestando la codardia con cui aveva troncato la domanda per la seconda volta. Ma Piero lo tolse dall’imbarazzo.
“Non recenti. Credo abbia due figli, non ho capito se siano alla materna o alle elementari. So che il primo è stato ricoverato, ma per fortuna non era nulla di grave. Se sia felice o no del suo matrimonio, non ne ho la più pallida idea.”
Le quattro frecce dell’automobile li immortalarono come il flash d’un paparazzo quando scattò l’antifurto. Poi tornò la discrezione del buio.
“E tu, sei sempre…?”
Di nuovo il candore gli impedì d’affondare la lama, temendo ci fosse ancora una ferita aperta.
“Se l’amo ancora? Certamente. Io il mio ‘per sempre’ l’ho pronunciato una volta per tutte. E’ curioso avere parlato per tutta la sera con questi giovani, che si lambiccano sulla autenticità del loro primo amore, mentre l’unico che conti, l’unico rispetto al quale abbiamo un reale potere è l’ultimo. Lei è il mio ultimo, unico, definitivo amore.”
“E non è come essere sposati? Per giunta con una che ti ha detto addio. E che, salvo miracoli, non tornerà mai da te.”
Piero cominciò a singhiozzare. Il prete temeva di essere stato troppo diretto, ma presto si accorse che l’amico stava ridendo. Proruppe anzi in una risata irrefrenabile.
La cosa lo indispettì, poiché proprio non se l’aspettava. Anzi, sapeva di meritare che almeno non lo si prendesse in giro.
“Cos’è? Perché ti ho fatto ridere?”
“No scusa, perdonami.”, rispose. Piero rialzandosi e soffocando le ultime risate, “Non volevo mancarti di rispetto. Ti rispondo subito. Però prima devo farti io una domanda.”
“Dimmi.”
“Tu da quanto tempo non senti Dio?”
“Oh bella!”, fece sguarnito il prete, “Io lo sento tutti i giorni. Io gli parlo di continuo.”
“E… ti risponde?”
“Avevi detto ‘una’ domanda…”
“Hai ragione. Ti domando ancora perdono. Rispondi solo a questa.”
“Sì mi risponde, sempre. Certo non con una telefonata”, don Patrizio si rammaricò di aver usato la stessa immagine utilizzata coi bambini della prima comunione; troppo tardi per trovarne un’altra, “Lo porto dentro di me, qui…”
Si indicò il centro del petto.
“Ecco, per rispondere alla tua domanda, sì, è come un matrimonio. Lei non ha sposato me, invece io ho sposato lei. E anche io la porto qui dentro”, prese la mano del prete e se la portò sul torace affinché si sincerasse di cosa palpitava.
L’uomo cinico che irrideva qualsiasi istituzione, era infine così vulnerabile? Il cuore che avvertiva pulsante sotto i polpastrelli, viveva una chimica del desiderio così potente e delicata?
Ritraendo la mano, con una punta di delusione, don Patrizio domandò schivo:
“E cosa rende un amore non corrisposto differente da un’ossessione?”
Chissà se parlava di Piero. Quello però non sembrò aversene a male:
“Nulla, eccetto che so di potermene andare in qualsiasi momento. Amare qualcuno nel cuore, solamente nel cuore, è una posizione sostenibile nella misura in cui si rinnova il voto ogni giorno sapendo bene di poterlo sciogliere quello dopo. Ma forse questo dovrebbe valere anche per le relazioni vissute nel tempo e nella carne.”
Esterrefatto il prete balbettò:
“Ma questa è la verginità.”
“Se lo dici tu… “, gorgogliò divertito Piero.
Ciò detto si abbracciarono a lungo, senza aggiungere parole.
Poi Piero salì sulla macchina. Le luci trafissero il confessionale dell’oscurità un attimo prima che il motore cominciasse a borbottare.
Quando l’auto stava per allontanarsi, a don Patrizio tornò in mente una cosa, quindi bussò frettolosamente sul finestrino. Il vetro stridette nella morsa di caucciù.
“Posso farti un’ultima domanda?”
“Dimmi…”
“Perché poco fa ti sei messo a ridere in quel modo?”
“Oh beh, perché in quel momento mi era venuta in mente la frase più assurda che un uomo come me potrebbe mai dire a un uomo come te.”
“E quale?”
“Che… non c’è nulla di male a credere nei miracoli.”
Poi diede ancora un buffetto al prete paralizzato. Il finestrino tornò nella posizione originale. I pneumatici cigolarono sulla ghiaia mescolata ai chicchi di riso cristallizzati dopo l’ultimo matrimonio, infine con un paio di colpi di sterzo si allontanò.
Don Patrizio lo seguì con lo sguardo fino a quando vide gli stop accendersi, e una luce intermittente segnalare la svolta a destra.
Poi fu di nuovo il buio.
Era esausto, ma non della stanchezza che gli capitava nelle giornate più faticose. Piuttosto era quella dei momenti difficili. Non necessariamente brutti. Quelli in cui avvertiva maggiormente la pressione a dover dare ragione di ciò in cui credeva e che lo teneva occupato in quel luogo, da così tanto tempo.
Come se avesse dovuto sopportare una visita a sorpresa di un “ispettore della fede”, che avrebbe valutato gli antri del proprio cuore, piuttosto che l’ortodossia delle azioni.
Ma non era preoccupato. Sollevato anzi.
Fischiettava mentre rientrava negli ambiti dell’oratorio. La mano gli prese a frugare la superficie interna delle tasche dei pantaloni. Non cercava qualcosa, ma voleva trovare, in quella serata elettrica, un qualsiasi oggetto familiare, che lo riportasse in un qui, un adesso dolce e resistente, senza farlo volteggiare troppo a lungo. Una esigenza che non sapeva neppure di avere. Le nocche rimbalzarono sul cuoio, istoriato e consunto del suo vecchio libro di preghiere. Era tutto ciò di cui aveva bisogno. Si sentì subito meglio.