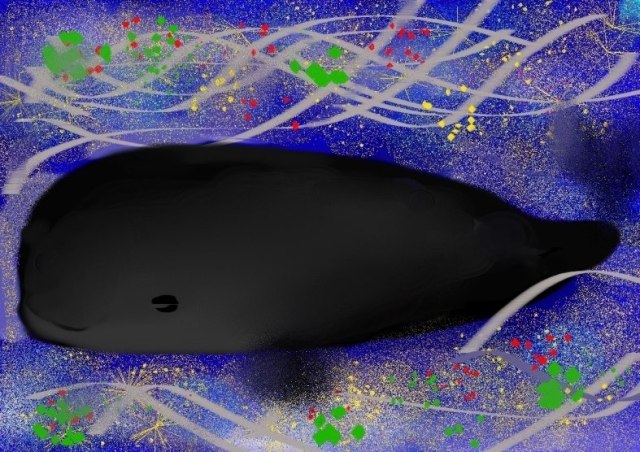Sulla Post-Truth
“– Quelli che vedi là – rispose il suo padrone – dalle smisurate braccia; e ce n’è alcuni che arrivano ad averle lunghe due leghe.
– Badi la signoria vostra – osservò Sancio – che quelli che si vedono là non son giganti ma mulini a vento, e ciò che in essi paiono le braccia, son le pale che “girate dal vento fanno andare la pietra del mulino.
– Si vede bene – disse don Chisciotte – che non te n’intendi d’avventure; quelli sono giganti; e se hai paura, levati di qua, e mettiti a pregare, mentre io entrerò con essi in aspra e disugual tenzone.”
Miguel De Cervantes. “Don Chisciotte della Mancia”
Jay Branscomb lo scorso luglio ha pubblicato su Facebook una foto che ritrae Steven Spielberg accovacciato sul corpo straziato di un triceratopo, improbabile trofeo di caccia. La didascalia recitava: “Per favore, condividete la foto, così che il mondo possa svergognare quest’uomo spregevole”.

Pochi secondi ed ecco che i social ingaggiano con l’insensibile assassino di animali estinti una vera e propria gara di insulti – una shitstorm, per la quale non occorre traduzione -, di indignazione e così via. Si sono contate qualcosa come 31.000 “condivisioni”, accompagnate dai più furiosi commenti, che andavano dal “bracconiere” ad altri assai più triviali. E’ tutto vero.
Il fatto che Jay fosse conosciuto per altri scherzi divenuti virali, e che Steven Spielberg, fosse il papà di creature improbabili come ET e gli spilungoni alieni di “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, non ha dissuaso i più. La foto per inciso era datata 1993, e proviene dal set del Blockbuster “Jurassic Park.”
Si potrebbe ridere, e classificare l’episodio come una di quelle amene vacuità che ci accompagnano nei mesi più caldi, e con cui i giornalisti titillano la pigra curiosità di chi sbadiglia sotto un ombrellone. Però, a mio avviso, ci si può ravvisare molto di più. Vi potremmo cogliere addirittura lo spunto per una vera e propria mutazione antropologica e filosofica, lasciando agli studiosi del comportamento unicamente il dibattito se sia già avvenuta per intero (personalmente mi collocherei in questo “partito”), parzialmente, se sia inarrestabile, oppure ancora se vi si possa – o se si deve – porre un argine.
Perché quante probabilità sussistono che i 31.000 sedicenti cretaceo-animalisti non avessero gli strumenti per comprendere si trattava di un fotomontaggio? Quanti tra essi, risalendo un fiume del Borneo potrebbero temere l’incontro con un Ittiosauro? Quanti ancora addentrandosi nella giungla del Congo riterrebbero effettivamente possibile lo sgradevole incontro con le fauci di uno Spinosauro affamato? Insomma, possibile che 31.000 persone siano il campione realistico di una moltitudine che ignora l’estinzione dei dinosauri avvenuta 65.000.000 di anni fa?
Probabilmente no, tuttavia il fenomeno è tale da non dover essere ignorato. Anzi, sono proprio quelle cifre il cardine della questione, perché alla vexata quaestio nella quale si sono compiaciuti per secoli i filosofi (in modo non sempre proficuo), ovvero cosa sia “veramente vero” e cosa no, trovano in questa massiccia forma di assenso parallelo, un proprio superamento, nonché una tardiva confutazione. Non si tratta in realtà di una nuova categoria, ma una digressione che si è determinata grossomodo negli ultimi cento, centocinquanta anni. Ma che solo negli ultimi trova una sua collocazione epistemologica nuova. Forzata finché si voglia ma nella stessa misura in cui gli avvenimenti costringono gli intellettuali a rivedere le proprie convinzioni.
Le 31.000 persone che hanno – a questo punto si può dire “banalmente” – dato il proprio assenso all’immagine del triceratopo non agivano una forma tradizionale della gnoseologia, ma venivano agiti da qualcosa di differente. Non hanno stabilito di dare il proprio “assenso” – che da qui in poi rappresenterà un vetusto processo per aderire al vero – a una proposizione, ma si sono lasciati trascinare da un impetuoso torrente verso valle. Da sempre esistono forme di consenso collettivo, e quando hanno trovato le afferenze e le sincronie necessarie per uscire allo scoperto, hanno lasciato più rovine che edifici. Dice in proposito lo psicanalista Luigi Zoja nel suo illuminante saggio sulla Paranoia.
“Gli impulsi alla pace non sono accompagnati da forti emozioni. Gli impulsi distruttivi sono invece inebrianti, soprattutto all’interno di una folla che diluisce la responsabilità e rinforza le emozioni.”
E ancora:
“Una folla abbassa l’intelligenza al livello inferiore dei suoi componenti…”
Due prerogative che accomunano l’attualità, ovvero l’inquietante rapidità del contagio – che non a caso si accompagna a fenomeni definiti virali -, e la prevalenza della collera rispetto a sentimenti più sociali.
Un elemento imprescindibile di questa accelerazione è determinato dalle nuove agorà virtuali ove si incontrano (o appunto si scontrano) le persone, i social e le piattaforme digitali, nelle quali l’altro è difficilmente oggetto empatico, per la semplicissima ragione che non viene percepito nella sua fisicità, nelle espressioni del volto, nella prossemica e nella storicità del suo essere, ma solo nel “profilo” che, strutturalmente ha solo due dimensioni, mancando della profondità. Sui social avviene una identificazione arbitraria in qualsiasi altro contesto, ovvero ogni persona coincide con l’ultima cosa scritta, e se si contrasta l’opinione così espressa, quasi inevitabilmente si detesta anche il suo latore. Si creano forme di aggregazione semi spontanea, attraverso un semplice click, dove da un certo punto in poi si incontrano solo quelli identici a sé, e gli altri esclusivamente quando si intende rovesciare il fiele accumulato.
E i nuovi politici, non hanno tardato ad accorgersene. Non è un caso se i fenomeni registrati dalla macropolitica – all’incirca dalla cosiddetta “Primavera Araba” fino a tute le elezioni più recenti, passando per la Brexit, gli indignati e le varie proteste no/tutto – si sono costituite con questa malta a presa rapida e scarsa tenuta. Fenomeni che montano con velocità inusitata, e con altrettanta rapidità si sciolgono a prescindere che l’obiettivo sia stato raggiunto o meno. Non siamo più alle prese con un “pensiero solido”, ideologicamente organizzato e perseguito con tenacia, quale poteva essere quello del ’68, o i giovani di piazza Tienanmen. Spesso dietro non c’è un pensiero evoluto, ma un germoglio sadico irrorato da scariche viscerali, tempeste che si addensano e scompaiono prima di essere socialmente rilevabili, e che entrano nei radar dei sociologi quando vengono intercettate e coartate da leader massimalisti. Spesso arroganti e con pochi scrupoli, “qualità” che in queste temperie vengono purtroppo premiate.
E’ quello cui stiamo assistendo. In un’epoca nella quale si dovrebbe godere delle conquiste dei decenni precedenti, in cui facilmente ci si fregiava della pseudo tolleranza volteriana, sintetizzata nell’incipit
“Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire.”
alla quale non hanno seguìto i comportamenti consoni, vedendo prevalere piuttosto l’oltraggio, gli imperativi su ciò che gli altri dovrebbero fare, sdoganando definitivamente l’insolenza.
Ma se a segnare il passo è stata appunto la tradizione illuminista e tollerante, ce n’è un’altra che a questa mutazione ha dovuto soccombere persino in misura maggiore. Vi abbiamo già fatto cenno.
La gnoseologia occidentale è la principale vittima del forsennato cambiamento cui siamo testimoni. Essa ha attraversato i secoli evitando che il suo caposaldo venisse messo in discussione, ovvero che c’è una distinzione chiara, univoca e indefettibile tra oggetto e soggetto; che “l’oggetto è oggettivo”.
Non si tratta di una sterile querelle filosofica, dibattuta da noiosi accademici barbuti nelle aule fatiscenti di un ateneo, perché parliamo di quella parte della filosofia che è diventata il cosiddetto immaginario collettivo dentro il quale, volenti o nolenti, siamo costretti a muoverci. Di più anzi, perché mentre quelle certezze nel dibattito degli addetti ai lavori sono state largamente messe in discussione – pensiamo all’idealismo in filosofia o alla meccanica quantistica – nella percezione dell’uomo comune, essa permane profondamente radicata. Confidiamo così tanto nella nostra capacità di cogliere realisticamente gli oggetti, che l’unica cosa di cui non dubitiamo mai è, altresì, quella più semplice: forse ci stiamo sbagliando. E che forse non possiamo non sbagliarci.
Dice Fritjof Capra ne “Il Tao della fisica”:
“Cercando di comprendere il mondo, ci troviamo di fronte alle stesse difficoltà che incontra un cartografo che cerchi di rappresentare la superficie curva della Terra con una serie di mappe piane.”
Un testo datato, ma estremamente attuale ed efficace. Se la nostra capacità di conoscere è simili alla cartografia piana, e la terra ovviamente sferica, ostinarsi nella strada della descrizione oggettiva, moltiplicherà i fraintendimenti invece che bonificarli.
E’ questo il dato curioso: i 31.000 indignati dalla caccia di Spielberg ai triceratopi sono esattamente gli stessi persuasi della “oggettività” delle proprie osservazioni.
Il dogmatismo, la pretenziosità nonché la conseguente virulenza delle prese di posizione, anziché contrapporsi dialetticamente sono invece posizioni concentriche.
Mi spiego.
Nel wrestling esiste una tradizione, denominata keyfabe, per la quale gli spettatori di un match “sospendono temporaneamente” l’incredulità – altrimenti opportuna – affinché ci si possa godere lo spettacolo. Solo questo consente l’efficacia della finzione scenica, gli eccessi di performance cui gli atleti si accreditano prima di salire sul ring. Quel bestione è davvero alto due metri e quindici? Possibile che siano centosessanta chili di muscoli? E’ davvero arrabbiato contro l’avversario?

Ecco, a noi manca la keyfabe. E poiché non siamo riusciti a immaginarne una, quando ad esempio parliamo di politica, o calcio, confondiamo sempre la realtà con una parte. E che continuerà ad essere una parte, per quanto noi si possa essere in buona fede. Specialmente. Non ci siamo attrezzati a suo tempo a comprendere che c’è un difetto d’origine nel rapporto tra cartografia e conformazione dei continenti (peraltro alcune tra le più curiose delle bugie sviluppate in rete parlano proprio di una terra che sarebbe piatta, oppure che l’esistenza della Finlandia sarebbe un costrutto mediatico), e quindi se le carte non funzionano sono i continenti a essere sbagliati. Non è un caso che le persone più pronte ad accumulare compulsivamente le “prove” oggettive, per le più strampalate tesi, sono proprio i paranoici.
Sui social si diffondono come macule del morbillo le più disparate fake news, si dibatte sulla postmodernità della verità (o sulla contemporaneità della frottola), e le redazioni dei giornali si affidano necessariamente ai debunkers, i commoventi paladini della “verità oggettiva”, pronti a demistificare con largo uso di documenti e di fotografie qualsiasi bugia, ma per quanto essi si sforzino non riusciranno mai a superare il difetto nel manico: non c’è una verità provata, non c’è documento fotografico in grado di inchiodare quel tale a quella circostanza. Perché non c’è una verità oggettiva. Già Leon Festinger, poco più di mezzo secolo fa, ha documentato irrefutabilmente che il nostro cervello è strutturato per sopportare solo una modica quantità di verità e di evidenza. Ed esclusivamente quella che ci serve di più, quella che si armonizza meglio con il nostro consolidato sistema di convinzioni. Per tutto il resto occorrerebbe magari un po’ di ironia.
Siamo stati inconsapevolmente indotti a pensare che la conoscenza fosse, per dirla con Tommaso d’Aquino, Adaequatio intellectus ad rem, e non sono state sufficienti tre critiche kantiane e tutto il dibattito successivo, a farci recedere da quel passo. Ma non era vero. La nostra conoscenza non è sufficientemente ampia e profonda per cogliere “la cosa in sé”; invero essa è uno strumento più rigido che imprime all’oggetto la propria stessa forma, per poi stupirsi della corrispondenza fittizia. Quando noi pensiamo di conoscere qualcosa avviene una sorta di esplosione controllata delle nostre connessioni sinaptiche, una innumerevole quantità di microscopici ictus cerebrali – l’immagine ovviamente no ha alcun fondamento scientifico, però rende l’idea – convogliano la rappresentazione di ciò che abbiamo di fronte nella melmosa palude di ciò che sapevamo anche prima.
Abbiamo aperto questa lunga riflessione con il noto passo di Miguel De Cervantes dove Don Chisciotte e Sancho Panza si confrontano sulla vera natura dei mulini a vento, e ogni lettore sa in partenza quale dei due personaggi sia un visionario patetico e chi il suo contrappeso realistico Sancho Panza. Solo Don Chisciotte può confondere, a causa della sua comica follia, a confondere per giganti i frantoi e le macine sulla riva del fiume. Ma è davvero così? Certo il lettore collude, per tutte le ragioni che abbiamo stabilito, col dimesso Sancho. Perché siamo stati educati nella stessa rappresentazione, che però è vera solo in quanto è stata accettata da una serie di attori sul proscenio. E che si tratti un mulino è la cosa che serve per evitare, appunto, di passare per folli o patetici, e per evitare di farsi più male del necessario. Oltre che per non alimentare paure più irrazionali, che tuttavia continuano ad abitarci più in profondità.
Ma si tratta ancora di utilità, non di verità. Cosa ci sia lì, oltre le convenienze e le paure, oltre a tutti i fulminei ictus che ci fanno convergere verso una determinata rappresentazione, non è dato saperlo. E forse Don Chisciotte potrebbe averci visto lungo.