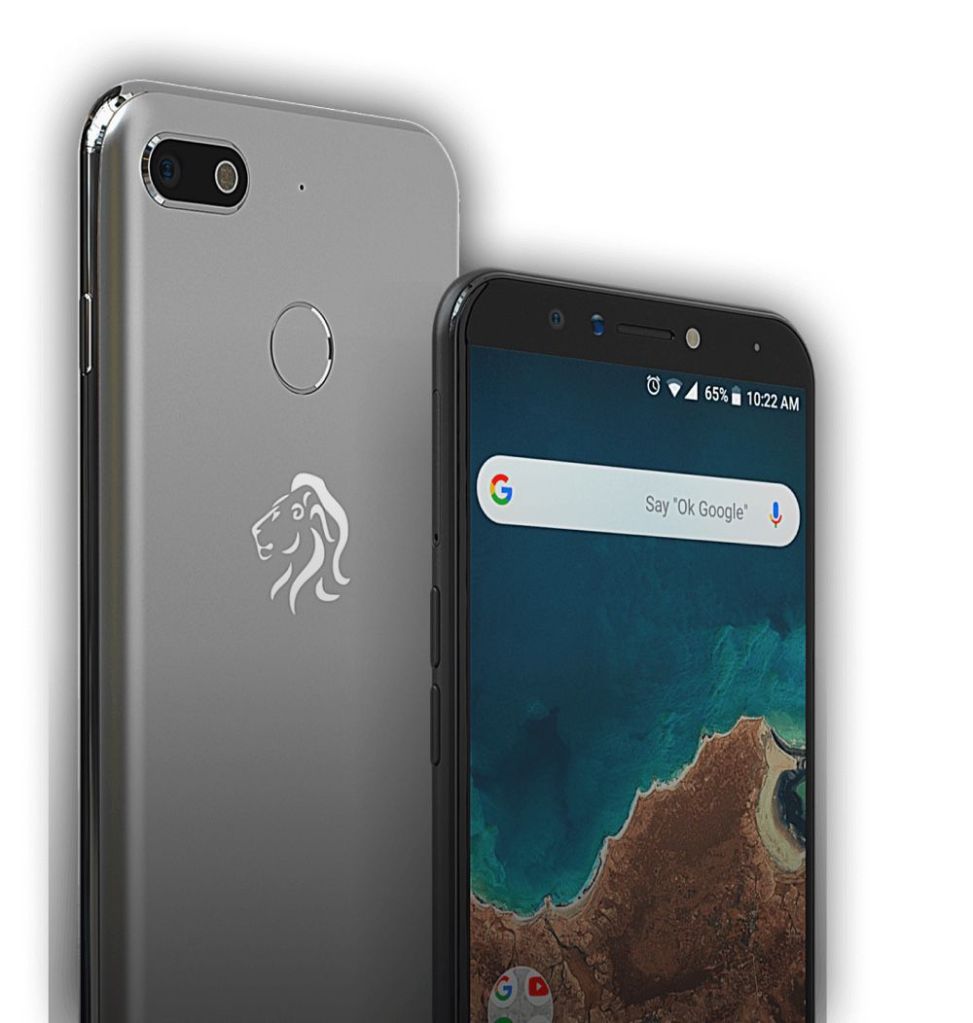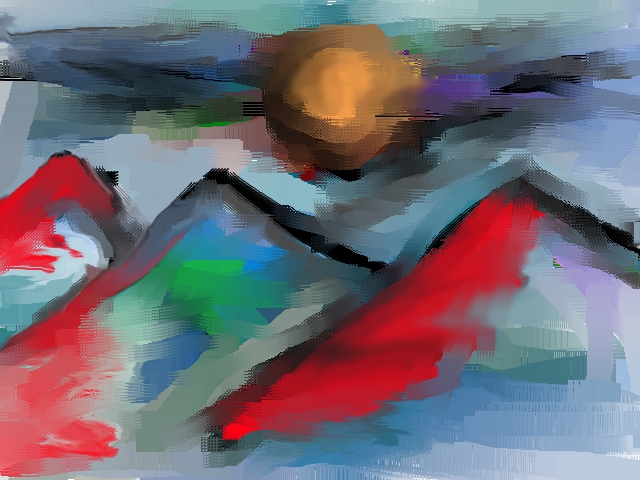Anche questa volta Netflix, con la miniserie Black Heart Rising, ha fatto centro. Una produzione britannica, dove con linguaggio duro, talvolta scabroso, riemergono gli aspetti conosciuti, al pari di quelli rimossi, del genocidio ruandese, che ebbe luogo tra aprile – con l’omicidio del presidente Habyarimana (Hutu) e nei cento giorni successivi, dove a perdere la vita sono stati quasi un milione di Tutsi, nei modi più raccapriccianti. Un genocidio vero, programmato con meticolosa precisione nei mesi precedenti. Gli ingredienti ci sono tutti: il delirio paranoico, le radio che trasmettevano h24 messaggi dove si inneggiava, appunto, al massacro, l’immancabile creazione di una milizia (preparata dall’esercito regolare, ma anche dai francesi che non volevano rinunciare ad alcune “opportunità”, costasse quel che costasse) che non aspettava che il momento di poter sprigionare tutte la violenza accumulata fino a quel punto. Il Ruanda, il paese più cattolico del continente nero – molti osservatori internazionali – a partire da Boutros Ghali, che non volevano farsi coinvolgere in una nuova Somalia, erano pronti a minimizzare sistematicamente i dati terrificanti che provenivano dagli osservatori, se potevano confidare che Habyarimana “tutte le domeniche andasse a messa”. Un odio ancestrale quello tra Hutu e Tutsi, che tuttavia era radicato in un passato non troppo remoto, perché la “distinzione” tra le due razze proveniva dall’occupazione del Belgio,il quale dopo la conclusione della prima Guerra Mondiale – non contento dei disastri compiuti nel limitrofo Congo – doveva immagazzinarne ancora qualcuno in quel paesino, poco più grande del Piemonte. E chi meglio dei missionari, i famigerati padri scheutisti che cominciarono a stabilire che una delle due razze, quella più armoniosa, con i lineamenti più slanciati, il naso sottile, nonché la minoranza non dovesse acquisire la leadership del paese? Nei decenni ci furono anche cambiamenti di prospettiva, sempre “lanciati dall’alto”, ma che riuscirono solamente a inasprire gli animi, a mantenere fiamme vivide sotto la brace.
La serie tuttavia non si svolge nel 1994, ma ai giorni nostri. La protagonista è Kathe una giovane donna britannica, figlia di Eve una esperta procuratrice, specializzata nel perseguire crimini “tiepidi”di guerre lontane del tempo. Lei in Ruanda, nel 94 c’era, ha visto l’orrore ed è riuscita a salvare proprio quella bambina, portandosela al salvo, in Gran Bretagna. La storia si apre quando l’indomita Eve accetta di perseguire, per conto della corte dell’Aja, un Tutsi, un “eroe di guerra”, membro del Fronte Patriottico Ruandese – quello del mai citato Paul Kagame -, l’organizzatissimo esercito Tutsi che, prima – e senza – le democrazie occidentali, aveva rovesciato le sorti del paese. Tuttavia il profilo di questo eroe viene comunque tratteggiato un po’ più ambiguo di quanto avrebbe dovuto: egli si presenta, da ruandese, al confine tra Congo e il paese delle mille colline, con una divisa diversa da quella ordinaria. Percorre a lunghi passi furiosi il tratto tra le sbarre che demarcano gli sbarramenti militari. Chiede di parlare con un ufficiale, e protesta a lungo che i suoi camion siano bloccati – da un po’ – dalla parte congolese. Cosa portassero quei camion non viene precisato, ma non occorre una immaginazione particolarmente fertile. Torniamo in Inghilterra, con Eve che parte per processare l’eroe Tutsi, raccogliendo per questo il feroce disappunto della figlia. Lei la il genocidio non l’ha vissuto, sebbene non ne sia stata risparmiata. Cresciuta con la consapevolezza di essere sopravvissuta, tirata via dai capelli da una morte certa e terribile, ora si oppone con tutta se stessa a vedere processare uno dei “buoni”, uno di quelli che il suo popolo ha provato a salvarlo. Ma le cose si complicano, intanto perché in Olanda la madre viene uccisa da un commando, insieme all’imputato designato. E il quadro continua a complicarsi, ad aggiungere colpi di scena, mescolando geopolitica e temi di una Spy Story, talvolta pertinente, altre invece ridondante (come ad esempio la descrizione di una leadership ruandese, che finisce per assomigliare allora stato maggiore del Pentagono. Anche troppi intrighi insomma, e non tutti di semplice lettura.
Ma il quadro che alla fine emerge è – uno dei colpi di scena – che Kathe non è in grado di sopportare. Intanto perché la sua storia non le era stata raccontata per intero: Kathe non è una Tutsi, come aveva sempre saputo, ma una Hutu. E sì era stata strappata da morte certa, ma non perché gli Hutu stessero massacrando la sua famiglia, ma perché i Tutsi, vinta la guerra in patria, avevano preso a rincorrere quelli che fuggivano oltre il confine del Congo. Proprio lì, in uno degli sconfinati campi profughi, teatro della prima e della seconda guerra congolese – un crimine che non vengano studiate a scuola – dove per caso è sopravvissuta a una epurazione dove erano morti 50000 Hutu inermi. Dapprima il dolore la fa avvitare in una spirale angosciante, poi piano piano comincia ad accettare la complessità delle circostanze, fino ad essere direttamente germinata da quella complessità.
La serie può concludersi qui, ma la rigidità di alcune parole inserite all’interno dei dibattito storiografico, invece dovrebbe cominciare proprio qui. Perché proprio il Ruanda, come nessun altro avvenimento, recente o non, non consente di collocare “gli eventi e le responsabilità” secondo dei rigidi canoni euristici per cui ci sono i cattivi, il cui unico compito è sversare tutto il veleno che hanno in corpo, e i buoni, che rimediano e puniscono quelli del primo gruppo. Queste sono categorie che appartengono all’uomo europeo, alla semplificazione tutta occidentale, al voler far chiarezza anche quando le circostanze storiografiche non consentono di andare oltre a una certa opacità. Purtroppo di buoni, senza macchia e senza paura che, animati da ideali sempiterni non ce ne sono. Non ce ne sono, probabilmente, mai stati. E’ vero che taluni eventi come la seconda guerra mondiale ci hanno quasi sequestrato all’interno di una lettura univoca ed infinitamente semplificata dei fenomeni storici. A soccombere non è la corretta visione dei torti da assegnare – Shoah ad esempio, ma non esclusivamente – e dei meriti da attribuire, ma quella di una rappresentazione della storia meno semplicistica. Quello Ruandese è un genocidio a tutto tondo – diversamente dalle troppe volte in cui giornali e politici si lasciano attrarre troppo dall’enfasi con cui è troppo facile lasciarsi sedurre da certe parole. Ma questo genocidio è pieno di sfaccettature, di travasi di sentimenti e di sangue, dove chi aveva – ha – la piena titolarità per fregiarsi di quel titolo, di chi ha pagato un enorme dazio in termini di vite e di sangue versato per le strade, in un altro tempo non ha esitato a usare approcci non troppo dissimili, sia per “vendicare” i genocidi della prima tornata, se non che – per me decisamente, se possibile, peggio – per lucrare sulla enorme quantità di materie prime reperibili – dal punto di vista ruandese – appena oltre il confine con la RDC, scatenando, insieme ad altri protagonisti, le due “guerre mondiali del Congo”, che pure non potrà essere considerato “un genocidio”, tuttavia il numero di morti del secondo (1997/03) al non invidiabile target di essere il secondo conflitto della storia umana più pesante in termini di tributi umani. Il tutto condito dalla naturale indolenza dei paesi più sviluppati (durante il genocidio ruandese qualche esperto di media francese aveva rilevato una avvilente statistica: la percezione pubblica dei media occidentali è sollecitata analogamente dall’omicidio di un “bianco” oppure da 87.000 africani: un bilancio sconcertante
E così, come gli Hutu durante il genocidio avevano goduto di una importante impunità (per esempio i francesi di Miterrand erano legati a doppia mano con gli insorti), altrettanto ha potuto fare con poche preoccupazioni gli uomini di Paul Kagame, eroe, presidente e dittatore Tutsi, invasore del Congo, sterminatore degli Hutu rimasti nei campi profughi, e che una volta scomputo il misfatto, rimanevano in loco, a causa delle sterminate risorse minerali, delle quali i congolesi sapevano poco cosa farci, mentre le milizie armate avevano un’idea invece molto precisa su come sarebbero riuscite a fare ripartire l’economia di Kigali. Certo significava riproporre lo schema che fu già del “sovrano illuminato”, Leopoldo II del Belgio, il “proprietario privato” (sic!) dello sterminato Congo tra il 1885 e il 1906. Per convincere quei “selvaggi” a raccogliere l’enorme quantità della gomma, resa indispensabile dalla nascente industria dei pneumatici, veniva imputata ai più pigri, o ai bambini che non potevano reggere certi ritmi di lavoro.
E così anche 90 anni dopo, gli M23 di affiliazione ruandese, si sono messe a soggiogare le popolazioni inerti con stupri, omicidi di massa, affinché quella gente si mettesse a cercare l’oro grigio, il Coltan, senza il quale i cellulari sarebbero una dolce utopia. Siamo noi gli utilizzatori finali del Coltan, è a causa nostra se il gigante congolese non troverà mai pace.
E intanto il Ruanda – immemore del genocidio di 29 anni fa, si è messo a produrre cellulari, i primi smartphone 100% africani. Africani, non ruandesi visto che i giacimenti di cobalto e coltan del paese sono del tutto insufficienti.